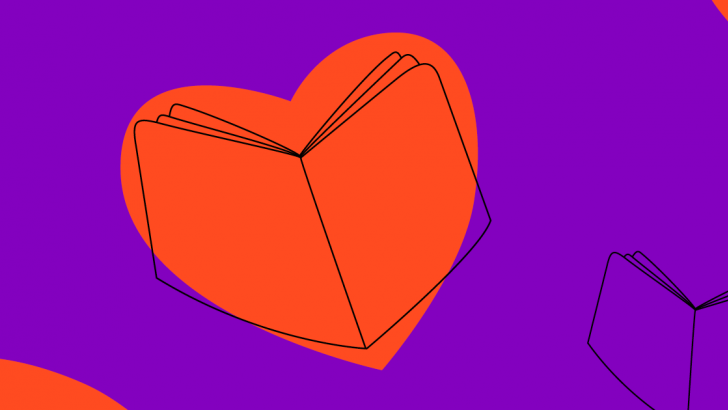CULTURA
Appunti per una ricognizione sintetica dell’opera di Giuseppe O. Longo

1. Da Giuseppe O. Longo, matematico e già docente a Trieste di Teoria dell’informazione per sua principale professione, sarebbe del tutto errato attendersi che, vòltosi alla letteratura militante e affermatosi quale autore di numerosi racconti (chiamiamoli per ora così), romanzi e azioni teatrali, abbia trasposto in siffatte scritture quella netta e obbiettiva distinzione tra vero e falso, tra certezza e dubbio, tra chiaro e indistinto che, almeno nell’immaginario di noi profani, regola e impronta la ricerca scientifica. E vale piuttosto la pena di riflettere che, se così fosse stato, la sua opera non eserciterebbe l’intensa fascinazione che, anche dalla lettura di qualche pagina soltanto, se ne ricava e che la distingue come unica nel panorama della nostra attuale, e presto dimenticabile, narrativa: la quale, vantando (naturalmente) impegno e concretezza, ama occuparsi di problemi individuali e sociali appiattendosi sulle forme minimali e sugli argomenti della labile cronaca (che essa chiama ‘realtà’).
Invece, l’impressione più immediata e inquietante che il lettore avverte affrontando per la prima volta la lettura di Longo è, per un verso, quella di una sua quasi totale estraneità al Mainstream del Novecento storico e del terzo millennio italiani, con i quali, forse, il critico potrebbe escogitare, senza frutto, solo qualche debole e arbitraria consonanza, del resto insignificante. Per un altro verso, sorprende il lettore, come se lo investisse una ventata del respiro grande della letteratura, un affollarsi di memorie e suggestioni alte, un senso di parentela più stretta con una più nobile famiglia, da Kafka a Conrad al Dürrenmatt de I fisici a Beckett a Borges e a taluni maestri della ingiustamente sottovalutata Science-fiction speculativa (per la pertinenza di quest’ultimo apparentamento è da vedersi almeno Il ministro della Muraglia. Racconti dell’abisso, 2010). Di qualcuno, di Kafka per esempio, è innegabile che Longo abbia subìto la diretta suggestione; d’altri non si saprebbero individuare crediti significativi; di qualcun altro credo verosimile che Longo non abbia neppure cognizione.
Ma qui non li ricordo quali possibili o, più spesso, improbabili fonti d’ispirazione, bensì per constatare che quest’aria di famiglia dipende piuttosto da una variante culturale di quella che i biologi chiamano ‘convergenza evolutiva’. Per chiarire questo concetto, che definisce sia la profonda, assoluta originalità della narrativa di Longo sia il suo collocarsi in degna compagnia, ricorrerò a un esempio. Molti personaggi di, poniamo, Conrad, dal protagonista e vittima di Sotto gli occhi dell’Occidente a Lord Jim, si inchiodano a un tragico destino di fallimento e morte per una sola scelta compiuta in un breve momento. Ebbene, come non pensare alla risoluzione fatale – il salto verso la creduta salvezza – del conradiano Lord Jim leggendo questo passo del romanzo di Longo La gerarchia di Ackermann (1998-2016)?:
Nell’attimo in cui Farkas mi porgeva i due biglietti e mi guardava di sotto in su coi suoi occhi gonfi da rospo, nell’attimo in cui io allungavo automaticamente la mano e mormoravo addirittura un ringraziamento a fior di labbra, in quel preciso momento si consumava la fine del mio matrimonio, la fine del mio rapporto con Giuliana e, in un certo senso, la fine della mia vita.
Va da sé che un tale raffronto non ha affatto, per se stesso, quella consistenza oggettiva che un tempo era la fata Morgana dei ricercatori di “fonti”; ed anzi è più che possibile che Longo sarebbe il primo a stupirsene e a protestarsene ignaro. Ma non è questo che importa: ciò che importa è il fatto che se un narratore si svincola, come Longo, dalla miserabile cronaca della vita qualunque e decide di affrontare gli snodi segreti e ardui della tragedia esistenziale, siffatte convergenze anche involontarie con quanti vi hanno pensato in grande sono inevitabili e, direi, necessarie.
Potrebbe aver agito come stimolo in questo senso la circostanza che Longo, pur romagnolo d’origine, abbia insegnato a Trieste e viva attualmente a Gorizia: luoghi che una tradizione critica e storiografica a dire il vero un po’ frusta designa quali luoghi, tra soggiorni di Joyce e contiguità con la Mitteleuropa, specialmente aperti alle conoscenze letterarie e musicali (noto incidentalmente che, per tacere di Bartók, musica di Mahler, Bruckner e Mozart, nell’ordine, si ascolta in una pagina del romanzo L’acrobata, 1994) e all’influenza di universi culturali più ariosi dell’ormai alquanto asfittica tradizione italiana. Longo stesso, nel romanzo già menzionato La gerarchia di Ackermann che a mio avviso meglio esprime la summa della sua poetica, muove la vicenda fra Trieste e Budapest, quasi tracciando il perimetro di un habitat memoriale meglio aderente all’identità di uno scrittore che si diriga verso le origini autentiche della narrativa moderna. Del resto, ove egli trovi opportuno dare un nome ai luoghi dell’azione, di regola lo attinge da una toponomastica appropriata o allusiva al magico spazio che si estende da Vienna a Tallin…
2. Il carattere che più si impone come saliente e identitario nei circa dieci volumi di racconti, nei due romanzi principali (L’acrobata e La gerarchia di Ackermann) e nelle azioni sceniche che fino ad oggi costituiscono l’insieme dell’opera di Longo è la quasi radicale rinuncia a costruire la narrazione come una sequenza ordinata avente, come già Aristotele prescriveva, principio, mezzo e fine. Nelle sue manifestazioni più estreme, il carattere per dir così non-aristotelico del narrare di Longo procede infatti sino alla distruzione radicale del racconto quale forma chiusa.
Così, non vi appare affatto necessario che la vicenda muova ordinatamente verso una conclusione, verso un epilogo che finalmente chiarisca il significato di eventi indecifrabili e inquietanti, fin allora disposti lungo un asse del tempo perturbato che sembra essersi avvolto in una spirale di cui la narrazione dà l’impressione di percorrere una retta che dall’estremità interna ne taglia le volute fino alla voluta più esterna (o viceversa), senza curarsi di raggiungere l’altro capo. Ne La gerarchia di Ackerman non escluderei che la funzione o gerarchia di Ackermann, definita dai matematici come ‘funzione ricorsiva non primitiva ricorsiva’ (qualunque cosa ciò voglia significare) e oggetto del corso di perfezionamento che conduce l’io narrante a Budapest senza che poi se ne parli più di tanto nel libro, abbia nelle intenzioni di Longo un qualche rapporto con il modo in cui è costruito il romanzo; ma, ignaro di matematiche qual sono, non posso dirne altro. Il misterioso plico giallo che potrebbe dare la ragione degli oscuri, persino torbidi rapporti tra il protagonista e i personaggi con cui nel romanzo egli si relaziona via via a Trieste e a Budapest, non verrà mai aperto; anzi, in un solenne rito di purificazione che monda e annulla i casi trascorsi, sarà, ancora chiuso, gettato in un canale dove lo vediamo affondare come se con esso scomparisse l’estrema possibilità di recuperare al giudizio razionale, e magari alla banalità, tutto ciò che è avvenuto o forse è stato solo sognato.
3. Nelle sue manifestazioni più estreme, il carattere per dir così non-aristotelico del narrare di Longo procede, come s’è detto, sino all’abbandono della struttura narrativa quale forma chiusa, tant’è che parecchi racconti si propongono come frammenti, aperti e chiusi da puntini di sospensione: cetera desiderantur, come nelle moderne edizioni di opere antiche che le vicissitudini della tradizione manoscritta hanno mutilato.
Che questa sorta di indecidibilità, con cui il lettore deve misurarsi nei finali aperti di molte narrazioni, non vada a scapito della compattezza di un pensiero ispiratore, o forse sarebbe meglio dire di una strategia fermamente applicata ad esplorare i lati oscuri dell’essere, è dimostrato dal carattere che hanno i molti libri in cui Longo ha riunito una eccezionale quantità di racconti. Essi, certo, ripropongono testi che per lo più erano stati già pubblicati in sedi e tempi diversi (come scrupolosamente dichiarano le bibliografie annesse), ma che una volta distribuiti nei rispettivi volumi conclamano la sostanziale organicità della raccolta che se ne costituisce, come è facile constatare, per esempio, nel citato Il ministro della muraglia o, ancor meglio, nei dieci racconti di Antidecalogo (2015): dove diresti che non di una silloge si tratti, ma di un’opera unica costruita per elementi discreti. Persino nelle raccolte a carattere più miscellaneo i titoli in copertina, sempre assai suggestivi, riprendono quello di un racconto che vi è compreso, credo non privilegiato a caso ma quasi a indicare come in una partitura musicale (per esempio in Congetture sull’inferno, 1995) la tonalità-base del tutto. Questa caratteristica reductio ad unum, a prima vista paradossale, si giova di un presupposto di quella che a me pare la poetica di Longo, e che mi proverò a definire in breve.
4. Nei racconti come nei romanzi di Giuseppe O. Longo poco importa che i personaggi abbiano un’identità per così dire stabile. Può accadere che un medesimo personaggio si chiami volta per volta Olga o Ljuba; o che l’io narrante e la terza persona si alternino a distanza di poche pagine nella medesima funzione diegetica. Inoltre, e più in generale, colpisce in tutta l’opera narrativa e drammatica di Longo la qualità dell’onomastica che ne designa gli innumerevoli attori: essa è di preferenza straniera, talora astratta o solo vagamente plausibile, talora allusivamente assurda (nell’azione drammatica Sulla rotta di Città del Capo, compresa nel volume Il cervello nudo, 2004, due dei tre personaggi si chiamano rispettivamente Compton e Burnett!), sempre comunque tale da evitare una identificazione banalmente anagrafica del titolare. Si pensa per questo riguardo all’onomastica, per esempio, nei drammi di Samuel Beckett: ma non si tratterebbe di parentela né di un’eco consapevole, bensì di quella convergenza necessaria verso obbiettivi troppo diversi dalle mediocri aspettative dei narratori dozzinali.
Quella, poi, che potremmo chiamare labilità dell’io narrante porta a escludere che l’autore vi si identifichi o almeno gli presti ipso facto una parte significativa del proprio vissuto particolare. Semmai, qualche notizia – non biografica, ovviamente – di se stesso Longo ha preferito affidarla ai modi sottilmente indiretti di un singolare Essay (non un ‘saggio’ nell’italiano senso corrente) Alcibiade. Una suite per bassotto (2015), attraverso il rapporto con il proprio cane. Ma in generale ciò che di sé egli riversa nella scrittura è la sua tutta personale visione, non del mondo (del quale non so quanto gli importi), bensì della condizione amaramente e irrimediabilmente ambigua e precaria di chi è costretto ad abitarlo.
Può essere, invero, che a talune ambientazioni (a Trieste, per esempio, o a Budapest, ma anche a Vienna o a Dublino) corrispondano città in cui per davvero Longo ha abitato e lavorato, tuttavia nelle sue pagine si cercherebbe inutilmente il cosiddetto colore locale: vie e contrade e canali dai nomi noti sono piuttosto evocati, persino nella raccolta Trieste: ritratto con figure (2004), attraverso l’inquietante deformazione che talvolta si sperimenta nei sogni quando luoghi che ci sono familiari sembrano e non sembrano se stessi, e accade, nell’incubo, di smarrirsi sull’indecifrabile uscio di casa. Nei suoi racconti, del resto, manca assai spesso anche questa ingannevole topografia: città in penombra e vie e vicoli notturni vi rimangono informi e innominate, puri tracciati di itinerari senza origine e senza meta, isole da cui l’evasione è frustrata per sempre.
5. Eppure da questa che può apparire rinuncia totale di Longo alla classica, razionale compiutezza delle forme narrative o drammatiche convenzionali, e alla rifinitura precisa e costante di personaggi e ambienti, accade via via al lettore – mentre prende atto della loro evanizione e magari, se è un lettore ingenuo, sulle prime ne rimane perplesso – di ricavare l’impressione di un solido e, appunto, classico governo del tutto. Il potente strumento che Longo adibisce a questa funzione ordinatrice è la sua scrittura, tanto più rigorosa e sorvegliata quanto più sfuggente è ciò che essa rappresenta, in una sorta di tensione equilibratrice tra certezza della parola e sfiducia verso la razionalità degli eventi.
Sorprende in specie, per uno scrittore che per molti aspetti cui ho accennato si pone inequivocabilmente entro, o magari oltre, la modernità, una memoria tanto estesa e tanto rispettosa dell’intera tradizione linguistica e stilistica della letteratura. A questo proposito, Longo ha scelto di esprimersi e di darne conto in uno dei suoi racconti formalmente più “esplosi”, Questo lo facciamo dire a Posthuma (ora in Prove di città desolata, 2003), che è in un certo modo anche l’apologia e il canto funebre per il libro stampato; e per taluni aspetti ‘converge’, nel senso libero che si è chiarito più sopra, con a Canticle for Leibowitz di Walter M. Miller e con la borgesiana Biblioteca di Babele. Nel racconto di Longo una misteriosa catastrofe futura ha distrutto la sterminata rete informatica ove erano state depositati tutti i testi di tutte le letterature, e nello stesso tempo ha fatto riemergere e riscoprire, come rovine di un remoto passato, i libri di una biblioteca dimenticata. Sono, questi relitti (dice un personaggio del ‘racconto’), i testimoni di quando «scrivere era faticoso, bisognava raschiare e penare e pensare»: e non dubito che qui Longo descriva il suo proprio tormentoso e insieme deferente rapporto con la fruttuosa difficoltà della scrittura. E ancora: «Ascoltare i passi dei libri è come ascoltare le voci dell’universo riverberanti di echi (il mormorio delle galassia)». Appunto, Longo scrive come se frattanto ascoltasse «le voci dell’universo» fruscianti fra le pagine dei libri, attingendone in primo luogo un lessico straordinariamente esteso dai livelli della letterarietà più raffinata a quelli della parlata tecnica e prosastica (da cociore, insomma, a torbierosa,lezardosi), ma anche mutuandone il rispetto della retorica e delle sue figure, come per esempio in La gerarchia di Ackermannnell’insistito ossimoro «oscurità luminosa», fino all’omaggio ai poeti in un tratto foscoliano (affettuosamente ironico?) quale «cavalcata solitaria, fumigante, torbierosa come un inno e delle Parche il canto» (in Prove di città desolata). La scrittura sofferta e rigorosa, la lettura meditativa delle pagine stampate ottengono così, nelle parole di un tecnico per il quale immagino che i processi veloci e inerti dell’informatica non abbiano segreti, una appassionata rivendicazione.
6. Giuseppe O. Longo non è uno scrittore facile. La lettura dei suoi romanzi e racconti non è, d’acchito, rasserenante; e il piacere che assicurano sia l’originalità degli argomenti, sia la complessità delle strutture narrative, sia la cesellatura del linguaggio non è immediato, richiede una sorta di iniziazione, un consapevole impegno del lettore a capire e ad accettare le regole del suo gioco. Ma di libri facili traboccano, per l’espace d’un matin, i banchi delle librerie…