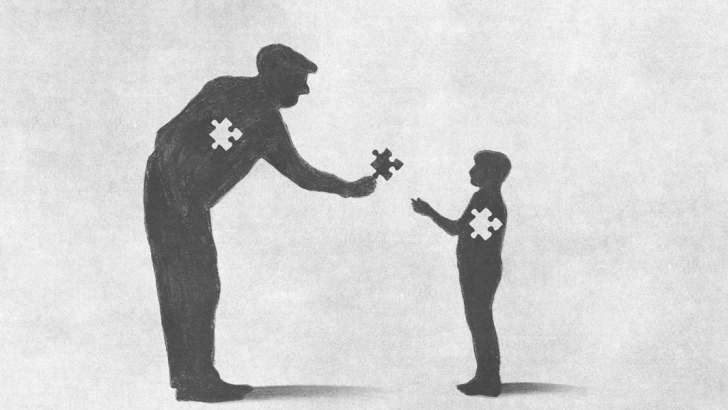CULTURA
Il pensiero ecologista e una prospettiva evoluzionistica c’entrano con Marx?

Il monumento dedicato a Karl Marx nella città di Chemnitz, Germania. Foto: Reuters
In queste pagine si respira spesso e volentieri, in modo più o meno esplicito, uno “sguardo evolutivo”, certo debitore del pensiero di Charles Darwin, ben considerato, rimeditato, criticato e talora connesso a discipline nuove (per lui) e alle aggiornate ricerche scientifiche. Anche il 12 febbraio 2025 (anniversario della nascita) è stato un Darwin Day, pretesto per parlare di evoluzione e dell’eredità dello studioso. La prima edizione italiana del volume L’Origine dell’uomo risale al 1875 (originale 1871). Ancora 150 anni dopo, a distanza di un secolo e mezzo, alcuni continuano a parlar “male” di Darwin, pure nel nostro paese, ma spesso non l’hanno letto. La seconda parte di quel volume è dedicata alla selezione sessuale (dopo aver ribadito la selezione naturale); la prima parte (sette capitoli) riflette su di noi, Homo sapiens. Anche le facoltà umane “superiori” dell’uomo (si possono forse citare: intelletto, senso del bello, coscienza, senso morale, capacità di giudizio, regole della convivenza) hanno delle gradazioni negli altri animali e, attraverso il processo di selezione naturale, si sono diversificate nelle versioni che troviamo negli esseri umani, variegate ma legate da un rapporto di continuità.
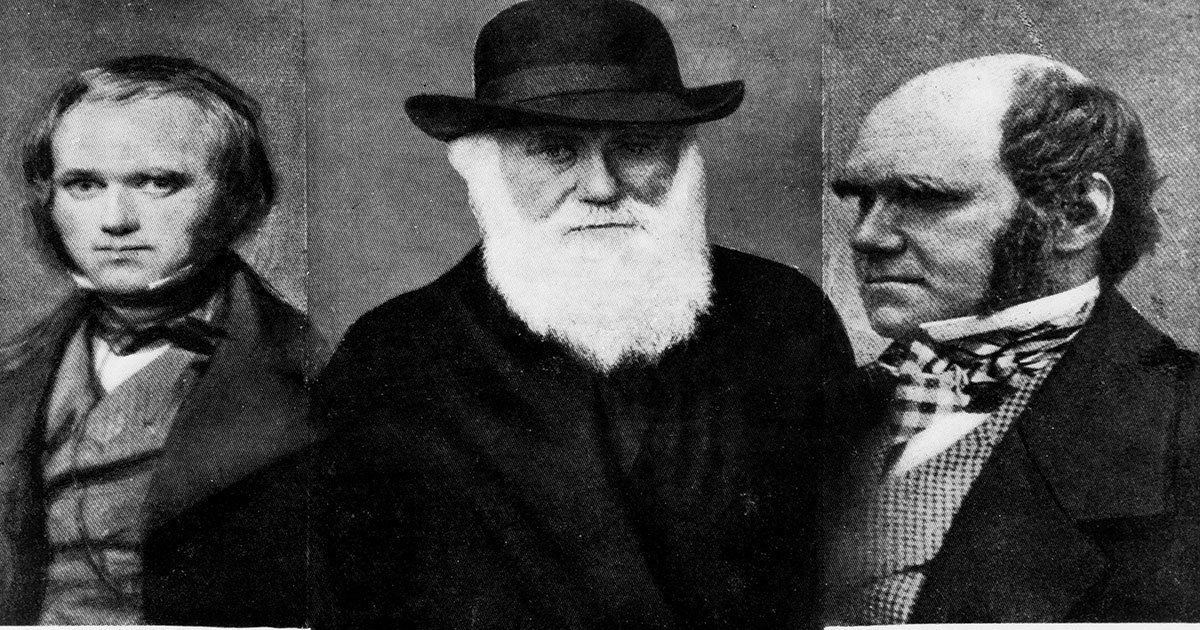
Charles Darwin
Secondo Darwin, la base della socialità umana sono gli istinti sociali che troviamo pure negli animali, che impregnano i comuni ecosistemi (e fondano biologia ed ecologia). In particolare, lo studioso parla della simpatia (ora si direbbe empatia): patire insieme, il sentirsi parte della comunità perché capiamo le sofferenze, le intenzioni e le motivazioni dell’altro, di chi appartiene allo stesso gruppo. Affiora qui un contenuto molto importante: la società umana è ambivalente, nata in piccoli gruppi umani, in tribù, talora in parallelo (e competizione) con altri clan, con altri gruppi. Per le specie umane e poi per la residua nostra specie si è creata via via una situazione “strana”: abbiamo imparato a essere solidali e a cooperare all’interno del nostro gruppo, facendolo diventare più coeso, organizzato e più capace di competere contro altri gruppi. Qui c’è il carattere ambivalente: siamo bravi a cooperare con chi pensiamo faccia parte della nostra stessa “fazione”, in parte perché siamo in competizione (o lotta) con chi non vi appartiene. In altri termini, la cooperazione e l’aggressività nascono probabilmente dalla stessa logica, quella relazionale di gruppo.
Abbiamo già visto che lo stesso pensiero evoluzionista di Darwin era stato in parte anticipato da antenati e poeti, in altri contesti e lingue. Più raramente si è, invece, qui riflettuto sul rapporto fra due pensatori quasi contemporanei e rimasti sempre a loro modo fertili e scomodi rispetto alle contraddizioni della socialità umana, Marx e Darwin, pur essendoci un qualche filo comune e forse un fragile nesso da decenni al centro di studi scientifici, risvolti culturali e attribuzioni politiche. Riprendendo un recente saggio (2018), Pietro Greco spiega che l'evoluzione biologica per selezione naturale costituirebbe il substrato di quel materialismo storico con cui Marx legge la storia umana. La teoria biologica di Darwin (1809 - 1882) risulterebbe, pertanto, il fondamento naturale della teoria politica e sociale di Marx (1818 - 1883).
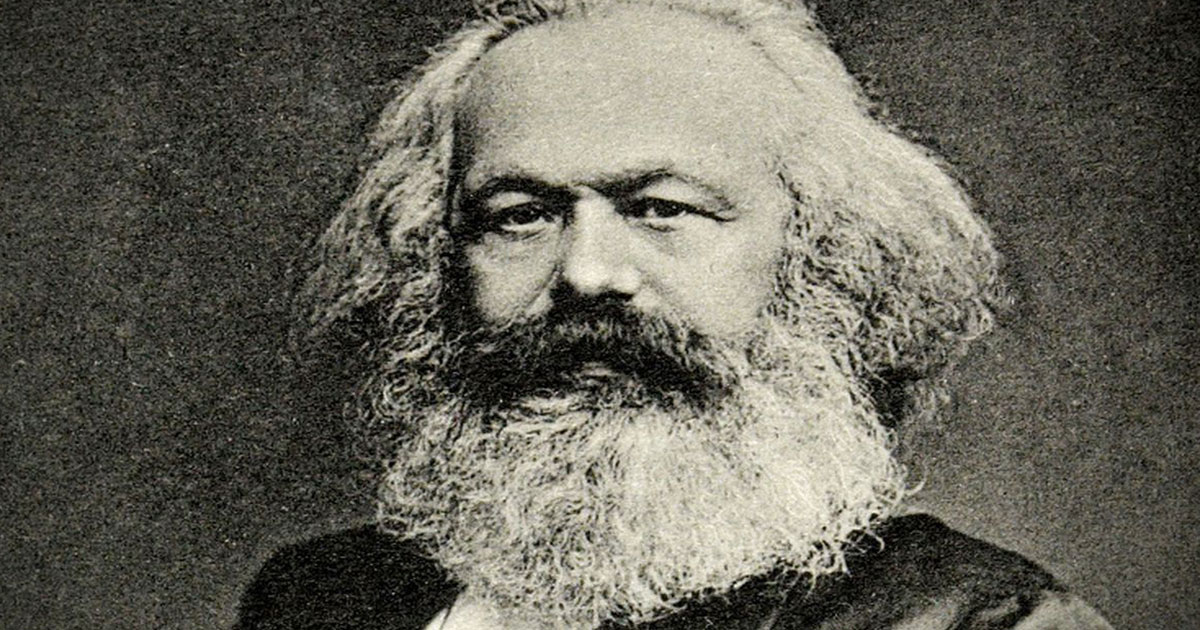
Kark Marx
Scoprire o riscoprire Marx
Ora un giovanissimo filosofo giapponese sembra aver scoperto o riscoperto l’ecologismo di Marx, il suo acuto interesse per la biologia (agli esordi) e per le altre scienze naturalistiche (o dure, o esatte) diverso da visione storicistica tradizionale e lineare, spesso attribuita a lui e ad altri scienziati sociali: si tratta di Saitō Kōhei con L’ecosocialismo di Karl Marx, traduzione (dall’inglese) di Emma Lenzi e Mariangela Pietrucci, Castelvecchi Roma 2023 (orig. 2017; orig. ed. tedesca 2016, come tesi di dottorato), pag. 388 e Il capitale nell’Antropocene, traduzione di Alessandro Clementi degli Albizzi, Einaudi Torino 2024 (orig. 2020), pag. 297. Come è evidente, l’autore parla moltissimo di Marx, poco o niente di Darwin e, probabilmente, Darwin non lesse mai nulla di Marx.
Il grande filosofo, economista, storico, sociologo, politologo, scienziato, scrittore, poeta, giornalista e politico tedesco (e chi più ne ha, ne metta) Karl Heinrich Marx (Treviri, 1818 - Londra, 1883) è stato a lungo considerato succube della idea ottocentesca fautrice del dominio assoluto dell’uomo sulla natura. Il presunto prometeismo antropocentrico e anti-ecologico di Marx è divenuto uno stereotipo diffuso, dato per scontato in chi si collocava a sinistra ed era ecologista nei decenni dagli anni Ottanta in avanti, un po’ ovunque nel mondo.
Forse Marx è stato frainteso, però. Si può, invece, forse, ricostruire in modo completo e sistematico una critica ecologica al capitalismo negli scritti marxiani, almeno dal 1844 al 1868. Si può, inoltre, comprendere tutta la portata della sua critica alla storia della tecnologia e all’economia politica solo se non si ignora la relativa componente e dimensione ecologica. Certo, la questione andrà in futuro ripresa e rivalutata: quasi sempre “evoluzione” in Marx ed Engels è sinonimo di progresso storico di fattura interamente umana.
La visione di Saitō Kōhei
Secondo Saitō Kōhei, Marx ci fornisce una delle più utili impalcature metodologiche per indagare le crisi ecologiche come contraddizione centrale dell’attuale sistema storico di produzione e riproduzione sociale. Certo, non fu in grado di completare il proprio sistema scritto di economia politica e alcuni anni fa mancavano ancora alcune essenziali edizioni critiche per le opere successive al 1868. Comunque, Marx non immaginava una visione utopica del futuro socialista, basata sulla crescita infinita delle forze produttive e sulla libera manipolazione della natura, e rivendicava, come compito essenziale del socialismo, sulla base di intense accorte letture di scienze naturali, la regolazione consapevole e sostenibile del metabolismo fra uomo e natura. La conoscenza da parte di Marx dell’Origine delle specie di Darwin è assai profonda, lo si sa da tempo.
Il giovane filosofo giapponese Saitō Kōhei (Tokyo, 31 gennaio 1987), dopo laurea e primi studi nella capitale giapponese, ha molto diligentemente ricercato in Connecticut (Stati Uniti) e a Berlino. Nel 2016 ha pubblicato, basandosi anche su manoscritti ed estratti in parte inediti, la sua tesi di dottorato Nature versus Capital, di cui nel 2017 è uscita la versione inglese rivenuta e corretta (il primo volume citato); nel 2019 ha curato il volume 18 della quarta divisione della Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA); ha vinto vari premi in Occidente, nel 2020 quello della Japan Society for the Promotion of Science; ha poi continuato a lavorare sui testi originali e cronologici di Marx, insegnando all’università sia in California che in patria; stanno uscendo altri suoi saggi scientifici (come il secondo volume citato) che hanno dato una svolta sostanziale a un senso comune interpretativo rivelatosi fallace. Partiamo dal suo testo inaugurale. L’ecologia di Marx non sarebbe né deterministica né apocalittica, vi sarebbero punti d’intersezione tra un progetto “rosso” e quello “verde” nel XXI secolo, al quale la teoria marxiana avrebbe ancora molto da offrire.
Saitō Kōhei è molto preciso nel contestualizzare la biografia intellettuale di Marx e nel presentare criticamente alcuni noti autorevoli interpreti del suo pensiero nel secolo scorso (per esempio Gorz e O’Connor). La prima parte è intitolata Ecologia ed Economia, distinta in tre densi capitoli: L’alienazione della natura come genesi della modernità; Metabolismo dell’economia politica; Il Capitale come teoria del metabolismo.
In sintesi: Marx sostiene che gli esseri umani si differenziano in modo decisivo dagli altri animali per la loro attività produttiva collettiva e unica, il lavoro, che genera valore e consente un’interazione “cosciente” e “intenzionale” con il mondo sensibile esterno; la rilevante crisi degli ecosistemi diventa poi attraverso la rivoluzione industriale una manifestazione della contraddizione immanente al capitalismo. La seconda parte è intitolata L’ecologia di Marx e la Marx-Engels-Gesamtausgabe, distinta in altrettanti capitoli sugli studi marxiani relativi alle scienze naturali, in particolare attraverso l’agricoltura e la chimica agraria, la geologia, la botanica: Liebig e Il Capitale; I fertilizzanti contro l’agricoltura di rapina?; L’ecologia di Marx dopo il 1868. Le conclusioni riassumono il campo di ricerca degli anni a venire, in parallelo con le prossime pubblicazioni della MEGA. Seguono una ricca bibliografia e l’indice analitico.
“ Noi esseri umani abbiamo mutato in modo irreparabile la Terra Saitō Kōhei
Il secondo volume
Il secondo volume è meno storico filologico e più teorico filosofico, parla di oggi e di come vengono affrontati i problemi sociali ed ecologici contemporanei. Il punto di partenza induce l’autore a un’opportuna sottolineatura: noi esseri umani abbiamo mutato in modo irreparabile la Terra. L’influsso delle nostre attività economiche è talmente diffuso sull’intera superficie del pianeta che da un punto di vista geologico siamo entrati in una nuova era, “Antropocene” (termine coniato dallo scienziato chimico Paul Crutzen). In particolare, è l’anidride carbonica nell’atmosfera che ha avuto un’impennata a seguito delle attività dell’uomo, determinando un grande effetto serra e i cambiamenti climatici dell’Antropocene. La ragione prima della crisi climatica, la chiave di tutto è solo ed esclusivamente nel capitalismo, messosi in moto con la rivoluzione industriale, e c’è (come l’autore ribadisce) un pensatore tedesco che l’ha dissezionato a fondo, Karl Marx, la cui opera più nota è appunto Il Capitale.
La critica ecologica al capitalismo negli scritti marxiani dal 1844 al 1868 verrebbe secondo l’autore rafforzata e precisata in modo completo e sistematico attraverso scritti, lettere e appunti nel quindicennio successivo. Così attraverso l’economia politica marxiana, Saitō Kōhei prova a definire aggiornati campi di azione culturale e sociale ribadendo le avvenute letture di scienze naturali da parte di Marx (pur senza poter ovviamente essere ritenuto né biologo né “evoluzionista”) e l’intuizione di una regolazione consapevole e sostenibile del metabolismo fra uomo e natura. Saitō (cognome) è dettagliato e fa affermazioni sempre nette; prende spunto da studiosi per disegnare un marxismo e una prospettiva diversi dal tradizionale; conferma che vi potrebbero essere punti d’intersezione tra un progetto “rosso” e quello “verde”, su cui molto insiste.
Dopo la prefazione molto perplessa sulle dannose buone intenzioni degli SDGs dell’Onu, i documentati capitoli sono poi otto (e i paragrafi centinaia, spesso brevissimi, con qualche figura illustrativa): Cambiamento climatico e modello di vita imperiale (che “trasla” le contraddizioni); I limiti del modello Keynesiano applicato al clima (considerati i Planetary Buondaries); La scommessa della decrescita (equa) nel sistema capitalista (almeno nei tanti paesi ricchi in cui ci sono pochi ricchi); Marx nell’Antropocene (con l’addio definitivo del primato della produzione e all’eurocentrismo); Accelerazionismo: una fuga dalla realtà (meglio tecnologie aperte); La scarsità del capitalismo, l’abbondanza del comunismo (ovvero di beni comuni condivisi); Il comunismo della decrescita salverà il mondo (ovvero rivoluzionare il lavoro in cinque punti); La leva della giustizia climatica.
Nel tentativo di andare oltre le riflessioni espresse con Il Capitale (l’unico volume editato dallo stesso Marx nel 1867; soprattutto dopo quel periodo si scrissero con Darwin), l’autore sembra a tratti sottovalutare la questione delle condizioni materiali riassunta nella famosa espressione (in parte polemica con Hegel): “Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere” bensì, al contrario, è il (nostro) “loro essere sociale che determina la loro coscienza”. Il comunismo storicamente determinato non è solo quello sovietico ma anche quello cinese (in “vigore”). Forse in Occidente non è sufficiente la mobilitazione seria, ben motivata e non violenta del 3,5 per cento delle persone a promuovere grandi cambiamenti per il 99 per cento e per le società (come sostiene Saitō nelle conclusioni, riprendendo il pur interessante studio di una politologa). Le note bibliografiche sono in fondo a ogni capitolo, mancano gli indici, sia dei nomi che degli argomenti.