
Alcuni lavoratori distribuiscono gli aiuti umanitari arrivati dal World Food Program in Yemen. Foto: Reuters
La storia è nota: il 20 gennaio scorso, appena riconquistata la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha immediatamente firmato una serie di ordini esecutivi: tra questi anche il “congelamento immediato”, almeno per 90 giorni, di tutti i programmi di aiuti all’estero, con una formuletta che non lascia spazio a dubbi: “Nessuna ulteriore assistenza estera dovrà essere erogata - è scritto nella nota ufficiale della Casa Bianca - se non pienamente allineata e coerente con la politica estera del presidente degli Stati Uniti”. Tutto legittimo: ma quella disposizione, che di fatto mette sotto accusa l’operato fin qui compiuto dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo internazionale (USAID), ha delle conseguenze di portata enorme. Perché l’Agenzia nel frattempo è stata di fatto smantellata (aveva oltre 10mila dipendenti, ne dovrebbero rimanere appena 290), e dunque è assai probabile che i programmi di aiuto che forniva in 65 paesi colpiti da crisi internazionali, incentrati principalmente sull’assistenza medica e alimentare, non avranno un domani. Secondo i dati ufficiali gli Stati Uniti avevano fornito, nel 2024, aiuti per quasi 32,5 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali inviati in Ucraina, Etiopia e Giordania. Trump ha spesso additato l’USAID come esempio di sprechi e abusi: che senz’altro ci saranno stati, ma ciò non toglie che gli Stati Uniti hanno fin qui svolto un ruolo fondamentale nella risposta alle crisi internazionali, fornendo circa il 40% dell’assistenza umanitaria mondiale. In assenza di quei fondi, diventa altissimo il rischio che quelle crisi possano trasformarsi in tragedie. Lo scorso novembre l’agenzia dell’Onu World Food Programme (WFP) aveva pubblicato il suo Global Outlook 2025 dal quale emergeva la necessità, per l’anno in corso, di disporre di 16,9 miliardi di dollari per poter rispondere alle esigenze alimentari globali e all’allarmante divario tra bisogni e risorse. Ma la quota che gli Stati Uniti avrebbero dovuto coprire non arriverà.
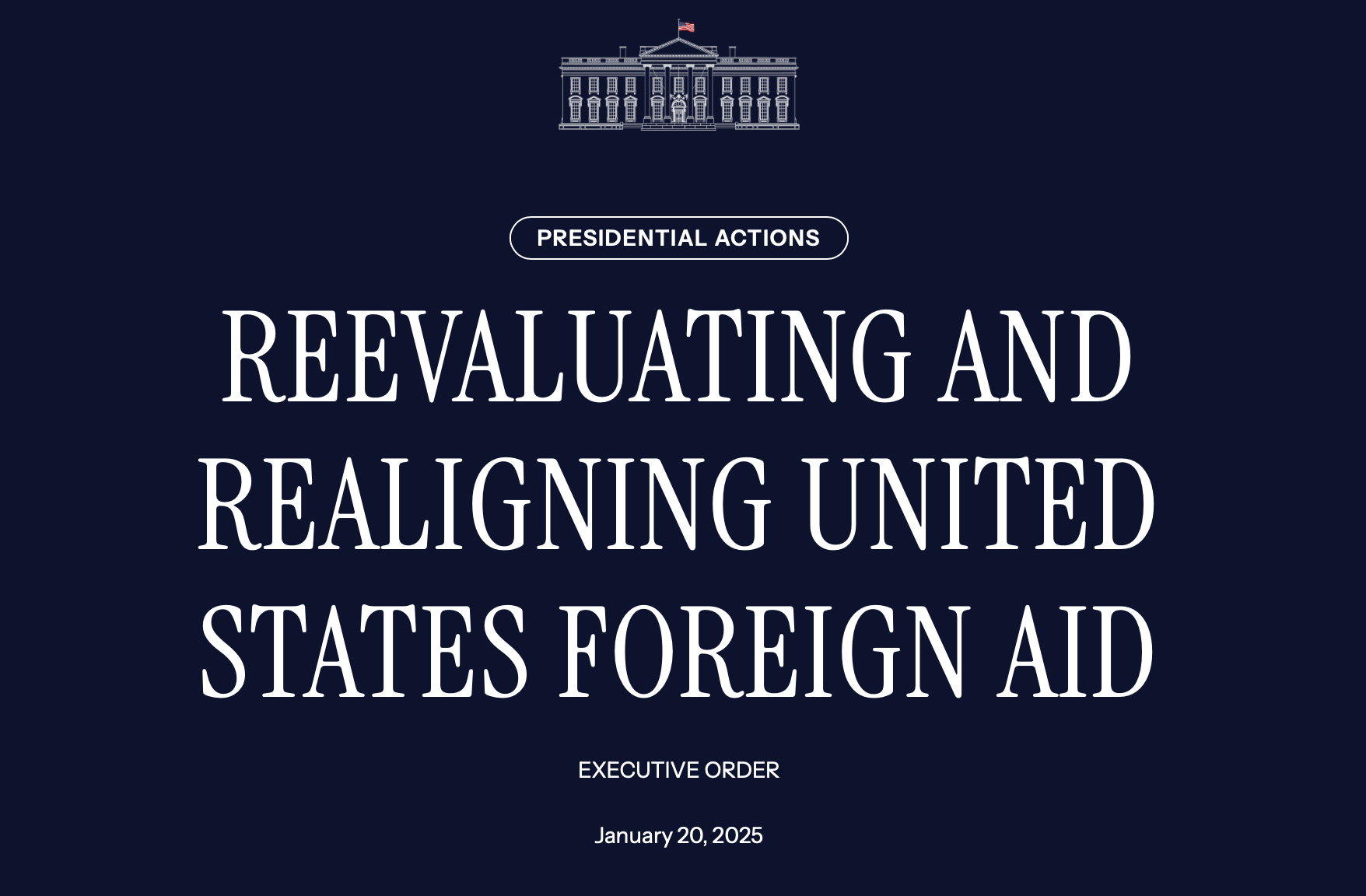
L'ordine esecutivo firmato da Donald Trump
Timori per la situazione in Yemen
Uno degli esempi più evidenti, e più drammaticamente attuali, riguarda lo Yemen. Qui oltre 19 milioni di persone, quindi poco meno della metà del totale della popolazione (stimata in 41 milioni), continuano a dipendere completamente dagli aiuti umanitari per soddisfare i loro “bisogni di sopravvivenza di base”. Situazione ulteriormente complicata dalla guerra civile in corso da oltre dieci anni nel paese arabo, dal momento che i ribelli Houthi (il gruppo politico e religioso armato filo-iraniano, che difende la minoranza musulmana sciita dello Yemen, gli Zaidi) controllano circa un terzo del paese: non soltanto la capitale Sana’a, ma anche una vasta area del nord e del nord-ovest, tra cui i governatorati di Sa’dah, Amran, Hajja e la città portuale di Al Hudaydah. Houthi che peraltro, dal novembre 2023, si sono resi responsabili di frequenti attacchi contro le navi commerciali occidentali in transito nel Mar Rosso meridionale e nel Golfo di Aden. Il che ha provocato la reazione di Israele e degli stessi Stati Uniti che, in accordo con Australia, Bahrein, Canada, Paesi Bassi e Regno Unito, hanno portato a termine una serie di raid nei mesi scorsi contro diverse postazioni Houthi.
Ebbene, nonostante questa situazione oggettivamente complessa (il 10 febbraio scorso le Nazioni Unite hanno annunciato la sospensione di tutte le operazioni umanitarie nel nord dello Yemen, come risposta agli arresti indiscriminati del loro personale da parte degli Houthi), gli Stati Uniti avevano sempre fatto la loro parte sotto il profilo umanitario: 685 milioni di dollari erogati nel 2024 (nel 2019 si era arrivati a 1,1 miliardi), per garantire alle persone più fragili assistenza medica, cibo, acqua potabile, un riparo decoroso, trattamenti mirati per bambini malnutriti, forniture igieniche e servizi igienico-sanitari, servizi psicosociali, protezione. Perfino le sanzioni, imposte all’inizio del 2024, erano state calibrate per “ridurre al minimo le conseguenze sulla popolazione civile”. Ora la brusca interruzione degli aiuti americani, per molti di loro, equivarrà a una condanna a morte. Joe Biden, nel 2021, aveva revocato la designazione a carico degli Houthi di “organizzazione terroristica straniera” proprio nel tentativo di mitigare una delle peggiori crisi umanitarie del mondo. Trump, evidentemente incurante delle conseguenze, ha subito reinserito i ribelli yemeniti nell’elenco riservato ai Foreign Terrorist Organizations. Ma un conto sono le guerre, un altro sono le azioni umanitarie, la solidarietà, il sostegno verso le popolazioni civili che nulla hanno a che vedere con i conflitti, dei quali sempre più spesso sono le principali vittime. Mescolare questi due piani, come vediamo continuamente accadere, è profondamente sbagliato e altrettanto pericoloso. Il mese scorso l’inviato speciale dell’Onu Hans Grundberg ha sottolineato la gravità della situazione soprattutto in funzione dei danni diffusi che i raid hanno provocato alle infrastrutture civili urbane (centrali elettriche, ospedali, sistema dei trasporti). Per non parlare della drastica riduzione delle operazioni portuali, dalle quali transita il 90% delle forniture mediche e circa il 70% del fabbisogno alimentare del paese, che attualmente operano al 30% della loro potenzialità. La coordinatrice degli aiuti di emergenza delle Nazioni Unite, Joyce Msuya, ha rimarcato ancora una volta che «le infrastrutture essenziali sono cruciali per gli sforzi di soccorso umanitario, e perciò devono essere tutelate, risparmiate, se non si vogliono provocare sofferenze dirette e immense ai civili». In particolare, la crisi sanitaria in Yemen è senza precedenti. Stando ai dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, dalla quale Trump ha appena deciso di ritirare gli Stati Uniti) lo Yemen ha registrato a fine 2024 la più alta concentrazione di casi di colera al mondo (250mila casi sospetti, con quasi 900 decessi). Mancano fondi per fronteggiare l’emergenza: l’Onu avvisa che soltanto lo scorso anno, tra marzo e novembre, sono stati costretti a chiudere 47 centri per il trattamento della diarrea (DTC) e 234 centri di reidratazione orale (ORC). Scrive l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (OCHA) nel suo ultimo report: “Milioni di yemeniti continuano a sopportare il peso del conflitto e a vivere condizioni di vita terribili. L’economia del paese continua a declinare, poiché gli shock climatici provocano lo sfollamento e interrompono i mezzi di sussistenza. L’azione umanitaria salva vite e salvaguarda la dignità delle persone: tuttavia gli operatori umanitari non possono porre fine alle sofferenze dei civili da soli. C’è bisogno di molto di più per ridurre i bisogni, raggiungere la pace, rilanciare l’economia”.
La Caritas: "Decisione sconsiderata"
Naturalmente non si tratta soltanto di Yemen: la decisione dell’amministrazione Trump, proprio per la statura internazionale che gli Stati Uniti hanno assunto negli ultimi decenni, avrà riflessi drammatici in ogni angolo del mondo. Tra gli altri, la Caritas è stata piuttosto esplicita nel sottolinearlo: “Riconosciamo il diritto di ogni nuova amministrazione di rivedere la propria strategia di aiuto all’estero” - si legge in una recente nota dell’organizzazione, firmata da Alistair Dutton, Segretario Generale di Caritas Internationalis, la confederazione che coordina l’attività di 162 organizzazioni cattoliche di soccorso, sviluppo e servizi sociali in più di 200 nazioni del mondo. “Tuttavia, il modo spietato e caotico in cui questa decisione insensibile viene attuata minaccia la vita e la dignità di milioni di persone. Fermare l’USAID metterà a repentaglio i servizi essenziali per centinaia di milioni di persone, minerà decenni di progressi nell’assistenza umanitaria e allo sviluppo, destabilizzerà le regioni che dipendono da questo sostegno critico e condannerà milioni di persone alla povertà disumanizzante o addirittura alla morte. Questo è un affronto disumano alla dignità umana”.
Una delle aree più colpite dalla decisione di Trump sarà l’Africa subsahariana, che soltanto nel 2024 aveva ricevuto circa 6,6 miliardi di dollari in aiuti. In Etiopia, avvisa l’Onu, 5mila operatori sanitari che dipendevano dall’assistenza degli Stati Uniti, sono stati licenziati dall’oggi al domani. Situazioni simili in Mali, nella Repubblica Democratica del Congo, nello Zimbabwe, dove ha chiuso un centro che tentava di sottrarre le ragazze più giovani dai matrimoni precoci. Nel sud del Messico ha chiuso pochi giorni fa, per mancanza di medici, un centro di accoglienza per migranti. Un articolo dell’Associated Press riporta inoltre che “in Colombia, Costa Rica, Ecuador e Guatemala, i cosiddetti “Uffici per la mobilità sicura”, dove i migranti possono fare domanda per entrare legalmente negli Stati Uniti, sono stati costretti a chiudere”.
Una strategia che balbetta
Anche la risposta globale contro la diffusione dell’HIV dipende prevalentemente dai fondi dell’USAID: il “President's Emergency Plan for AIDS Relief” (PEPFAR), lanciato nel 2003 dal presidente George W. Bush, finanziava finora il 70% delle spese. Secondo il programma delle Nazioni Unite UNAIDS, dalla sua creazione il programma ha salvato oltre 26 milioni di vite investendo in programmi di prevenzione, supporto, trattamento e cura dell’HIV in 55 paesi. Lo scorso gennaio, al momento di entrare in carica, il nuovo segretario di Stato, Marco Rubio, nominato amministratore ad interim di USAID, aveva dichiarato: “Ogni dollaro che spendiamo, ogni programma che finanziamo, ogni politica che perseguiamo deve essere giustificato dalla risposta a una di queste tre domande: rende l’America più sicura? Rende l’America più forte? Rende l’America più prospera? Daremo priorità agli interessi nazionali fondamentali dell’America, un dollaro alla volta». Nessun cenno alla solidarietà. Da allora alcune deroghe sono state introdotte (gli aiuti ad Haiti, per fare un solo esempio), poi nuovamente bloccate, il che la dice lunga sulla qualità e sulla chiarezza della “strategia” dell’attuale amministrazione americana. Secondo l’organizzazione Brookings Institution, non sarebbe da escludere l’ipotesi di una marcia indietro sull’abolizione dell’USAID, a causa di preoccupazioni legali e costituzionali, ma non soltanto. Scrive la Brookings: "Gli sforzi di USAID per prevenire i conflitti in tutto il mondo, incoraggiare i processi democratici e pluralistici e proteggere i diritti umani, ridurre la sofferenza per morte e malattia, incoraggiare una crescita economica sostenibile e prevenire la distruzione ambientale riflettono l’essenza degli Stati Uniti. Aiutano a costruire un ambiente internazionale che è funzionale agli interessi e ai valori degli Stati Uniti”. Chissà se domani sarà ancora così.




