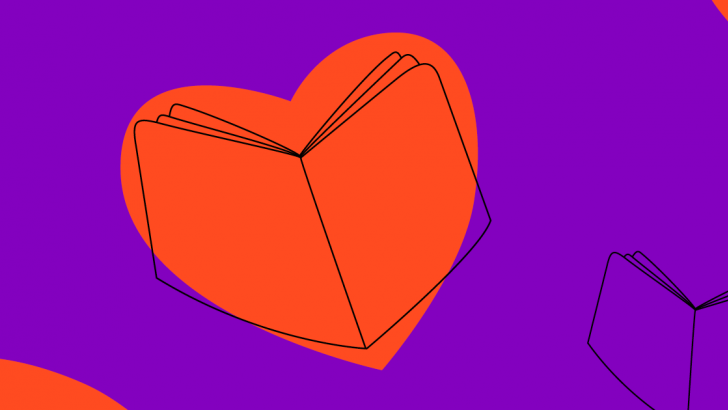“Troppe note, signor Mozart” si dice abbia detto l’imperatore Giuseppe II al compositore, dopo aver ascoltato Il ratto nel serraglio, il quale pare abbia ribattuto: “Non una in più del necessario”.
Un’obiezione simile potrebbe essere mossa a Daniele Petruccioli, per il suo La casa delle madri (Terrarossa, 2020) in dozzina allo Strega: troppe parole, troppe parentesi, troppi incisi, troppe circonvoluzioni.
Eppure non è così.
Ma c’è di più: lo scrittore in questo romanzo corposo sfida un diktat della narrativa dell’ultimo secolo, lo show don’t tell. Perché il narratore in terza persona della saga familiare che si svolge sotto i nostri occhi ne La casa delle madri non lesina spiegazioni: si potrebbe quasi dire che il racconto sia volutamente intessuto di ragionamenti come se seguissimo il modo di evocare fatti e le ragioni degli stessi di una persona ciarliera e brillante. Un pensiero apre la via al successivo – anzi, talvolta non è nemmeno concluso che urge già la necessità di specificare dell’altro – così in una ridda di legami consequenziali in cui il lettore, per fortuna, non perde il filo.
Petruccioli con la sua capacità di mimesi ci porta di continuo sulla spalla, sul lobo dell’orecchio, in punta di labbra dei personaggi che muovono la storia – anzi, che dalle vicende vengono travolti – senza però diventare mai loro. In questo modo prende le distanze da una certa tendenza della narrativa contemporanea: in tutto il romanzo non c’è un solo, singolo, dialogo.
Protagonisti indiscussi degli eventi sono Elia ed Ernesto, gemelli, il secondo dei quali al momento di nascere ha il cordone ombelicale quasi spezzato costringendo il ginecologo a tirar fuori il primo col forcipe di fretta e furia, maldestramente, causandogli una lesione cerebrale che lo segnerà per sempre. Se già ontologicamente i gemelli vivono una relazione con la vita che è, di fatto, “a metà”, oppure “il doppio” – a seconda del punto di vista –, in questo specifico caso la simbiosi si fa violenta, negata, l’interdipendenza diviene colpa, mancanza, ingiustizia. Ma c’è Sarabanda (nomen omen), la madre, a far da sponda, finche non muore, troppo presto. Lei è il personaggio più luminoso e potente di tutta la storia, quello per cui vale la pena leggere sperando che le pagine che raccontano di lei, dei suoi pensieri e delle sue azioni (a volte mancate) non finiscano mai. Sarabanda è una donna così imperfettamente completa da recar sollievo a quelle che – tutte probabilmente in una cert’ora della vita – si rendono conto di essere padrone della propria diversità, si tratti questa dell’incapacità di cucinare il ragù o le lasagne, o del desiderio di mettere fine a un matrimonio con uno Speedy (questo il nome del marito) che non basta mai perché fugge, o infine di indugiare in una certa profonda lievità che però non riesce mai a sciogliersi in lacrime.
In tutto il libro l’autore sfida la “normalità”, scardinandone il concetto, e al contempo ne intride le pagine fino al midollo, se per normalità o per diversità – spesso i contrari si toccano – consideriamo la vita nelle sue singole, uniche, incontestabili – perché esistenti – manifestazioni:
“Sarabanda non voleva che a suo figlio pesasse la sua diversità. Non era giusto. Peraltro, da donna combattiva, ce l’aveva con la meschinità sociale che per paura della diversità (ancora la paura) si vendica contro di essa, la ostracizza, quando poi la uccide: Sarabanda non voleva permettere a questa meschinità di fare del male al suo bambino. Così, si era mossa su due direzioni, anche se a loro volta uguali e contrarie (queste continue ramificazioni sono un po’ stancanti, ma la vita è così, le persone sono così; siamo tutti così, anche quando la nostra stessa tortuosità ci stanca tanto che ci rifiutiamo di prenderne atto): da una parte lavorava su Elia (perché sapeva, o sperava, che sarebbe stato il primo riferimento di Ernesto, dopo i genitori, almeno per i primi anni), cercando di inculcare in lui il valore della diversità e una conflittualità (ancora il conflitto) indomita contro tutto quello che la società avrebbe potuto aspettarsi da lui; dall’altra insisteva con Ernesto un po’ perché superasse i suoi limiti (ginnastica correttiva prima, poi sport di tutti i tipi, a prescindere dall’interesse e dalle apparenti possibilità del bambino) e un po’ perché non li considerasse, perché imponesse se stesso come – orgoglioso – spazio di normalità, in sfida al mondo”.
LEGGI ANCHE:
La dozzina del Premio Strega 2021
Le interviste per il Premio Strega 2021: Teresa Ciabatti
Le interviste per il Premio Strega 2021: Giulia Caminito
Le interviste per Il Premio Strega 2021: Maria Grazia Calandrone
Le interviste per il Premio Strega 2021: Andrea Bajani
Le interviste per il Premio Strega 2021: Emanuele Trevi
Le interviste per il Premio Strega 2021: Donatella Di Pietrantonio