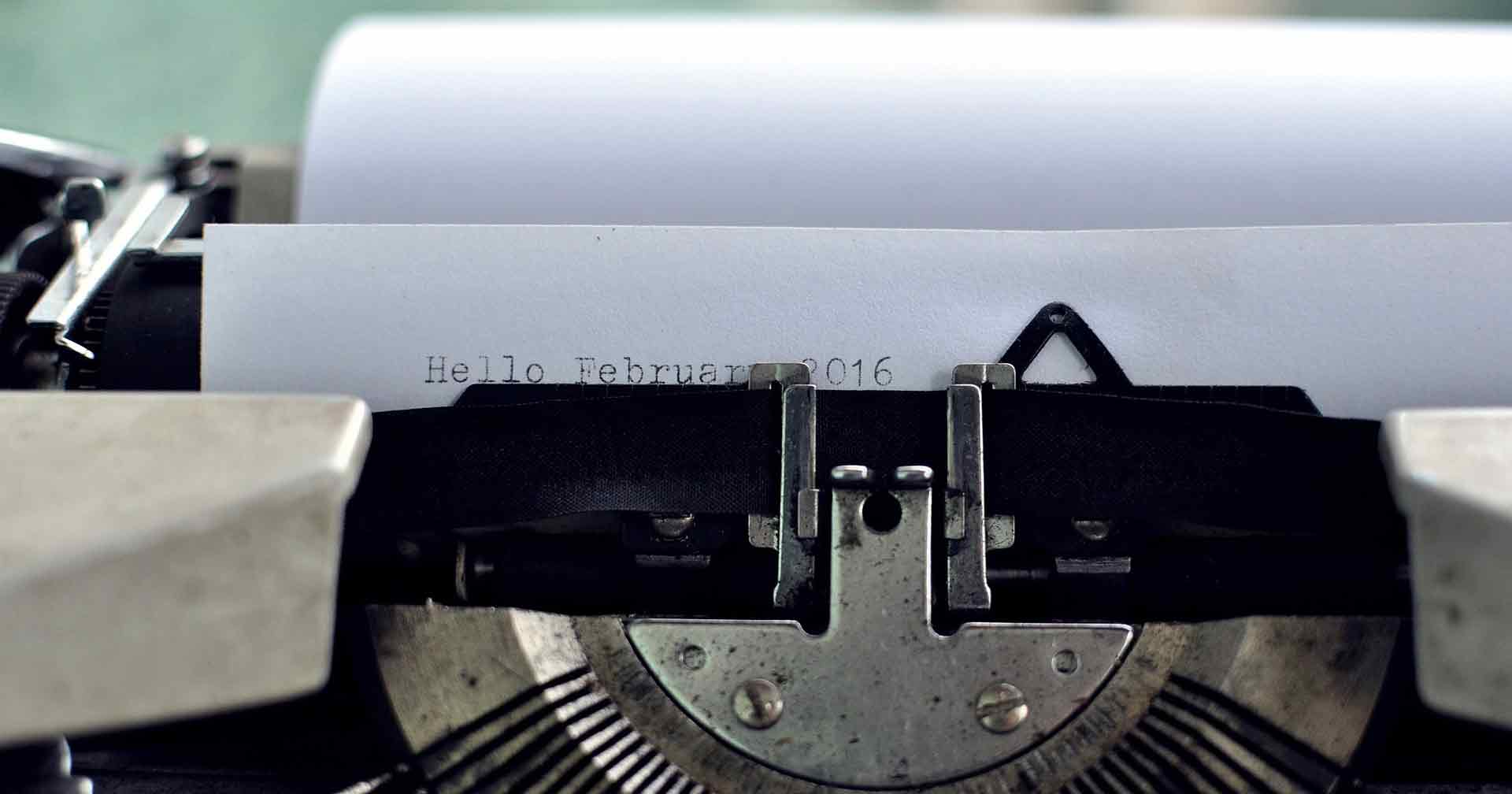
Se avete qualche “amico” (anche virtuale, da cui le virgolette) che di lavoro fa il traduttore, potrete imbattervi sulla sua bacheca in post fatti così:
o così:
in cui cioè viene in parte disvelato il mistero della traduzione, cioè in cosa consista operativamente il mestiere del traduttore. A volte nel saper decidere, appunto, come chiamare un pezzo di carne, o una stoffa.
Siamo così abituati a leggere testi senza domandarci come fosse l’originale che nemmeno pensiamo al fatto che qualcuno abbia trasposto l’opera da una lingua all’altra per rendercela accessibile. E che parole, contesti, frasi che hanno un significato apparentemente scontato spesso siano frutto di una mediazione, operata dal traduttore appunto, che inevitabilmente lascia una traccia nell’opera. Nel post “sulla macelleria”, dopo aver vagliato e discusso più di una cinquantina di commenti, la traduttrice Monica Pareschi scrive che opterà per “stracotto”. Quando leggeremo il testo tradotto, probabilmente alla parola stracotto non dedicheremo più di un secondo, forse due.
E dei traduttori a malapena conosciamo i nomi. Di recente però il riflettore si è spostato, e inquadra, oltre all’autore, anche chi lo traduce. Uno per tutti Fabio Cremonesi, legato ormai indissolubilmente alla firma di Kent Haruf, lo scrittore americano lanciato dalla casa editrice NN Editore (dopo quella italiana molte le traduzioni in altri paesi) e autore di Trilogia della pianura (Canto della pianura, Crepuscolo, Benedizione) e Le nostre anime di notte. Haruf è morto nel 2014 e in Italia Cremonesi è divenuto in qualche modo la sua voce post mortem, incontrando i suoi molti lettori in libreria o ai festival e facendosi portatore, in vece dell’autore, della sorte dei romanzi. C’è da dire che NN Editore, per esempio, in terza di copertina oltre alla biografia dell’autore riporta, con pari dignità, quella del traduttore.
Ma in che modo il traduttore interviene nella vita dell’opera?
Monica Pareschi, l’autrice dei post summenzionati e che per i tipi della NN ha tradotto di recente il romanzo Salvare le ossa di Jesmyn Ward, ma cui dobbiamo alcune traduzioni di Doris Lessing, Mark Haddon, Miriam Towes, Charlotte Brontë, Paul Auster e di moltissimi altri, intervistata in merito al suo lavoro, e in particolare a quanto “si perda” a leggere in traduzione risponde:
“È certamente vero che qualcosa si perde, ma la vedrei in termini di arricchimento, più che di perdita. Se noi pensiamo al testo come a una partitura, allora esiste un Bach suonato da Pollini ed esiste un Bach suonato da Benedetti Michelangeli. E possiamo pensare che entrambe le esecuzioni in un qualche modo ci portino verso la realtà della partitura, o del testo della musica, o del testo letterario. Quindi una traduzione, se è una buona traduzione, è una vita ulteriore del testo”.
“ Se noi pensiamo al testo come a una partitura, allora esiste un Bach suonato da Pollini ed esiste un Bach suonato da Benedetti Michelangeli
Lei, a ben vedere, oltre che traduttrice è anche scrittrice (È di vetro quest’aria, Italic 2014) e ritiene che la “frequentazione” di altre lingue dilati il suo uso di quella italiana, ma che viceversa quando traduce sia fondamentale zittire la propria voce e invece entrare in consonanza con quella di chi scrive. D'altra parte molti sono invece traduttori puri, non sono cioè scrittori a loro volta, come ad esempio Susanna Basso, cui dobbiamo la versione italiana dei romanzi di mostri sacri come Ian McEwan, Martin Amis, Julian Barnes, dei premi Nobel Alice Munro e Kazuo Ishiguro e di molti altri.
Inutile dire che ciascuno affronta il testo in modo diverso: chi lo legge prima tutto per puro piacere e poi lo traduce, chi traduce invece alla prima lettura, chi sente il bisogno di confrontarsi con l’autore dell’opera e di coinvolgerlo nella traduzione e chi invece sa che ciò non gioverebbe, chi viene spinto dalle parole altrui a cercarne di proprie e chi invece ne resta in qualche modo così soggiogato da non volersi misurare con la creazione ex novo, o semplicemente non sente questo richiamo.
In occasione del festival Incroci di civiltà a Venezia, qualche mese fa, Susanna Basso ha dialogato sul palco con Ian McEwan, di fatto per la prima volta in trent’anni, sul loro lavoro “insieme”. Lei, per esempio, è una tra quelli che nel tradurre non intesse un rapporto diretto con gli scrittori perché, dice, non sarebbe in grado di sintetizzare quello che vorrebbe chiedere loro: “Ciò che mi piacerebbe sapere è come fanno a scriverle, quelle opere”. E al termine dell’incontro le abbiamo rubato uno dei segreti del mestiere. La pazienza. Il sapersi aspettare. “Non tutto si può fare in un primo tempo” spiega. “Ci sono cose che in un secondo tempo possono arrivare, anche parole che non si trovano e che in un secondo tempo si possono poi trovare”.
“ Non tutto si può fare in un primo tempo




