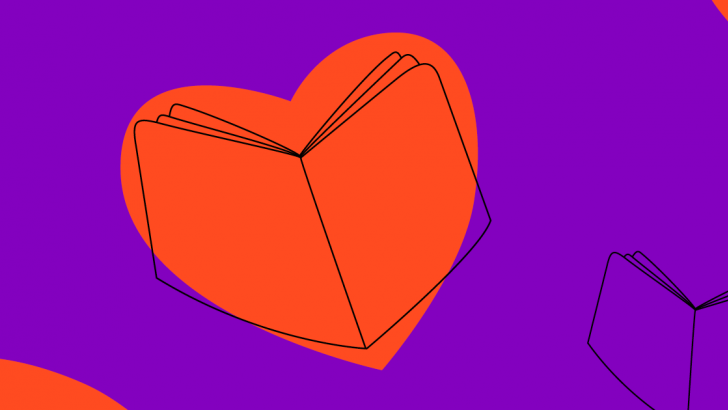Un capolavoro sfortunato, almeno qui da noi. L’uomo che amava i cani, dello scrittore cubano Leonardo Padura, fu pubblicato per la prima volta in Italia nel 2010, poco prima che la casa editrice chiudesse. Scarsissima circolazione, quindi; e fu un vero peccato. Perché, fra i tanti bellissimi libri dello scrittore cubano (dalle storie noir del tenente Mario Conde nell’Avana del periodo especial ai corposi romanzi a cavallo tra l’attualità e i secoli passati), questo è sicuramente il più maturo, il più complesso, il più affascinante, perfino il più vittoriosamente ambizioso. Ora, per fortuna, Bompiani lo ripubblica (traduzione di Eleonora Mogavero, pp. 622) e lo rende di nuovo accessibile al lettore italiano.
Sotto un titolo che riprende quello di un racconto di Chandler, Padura affronta un episodio storico come l’omicidio di Lev Trotskij a Città del Messico nel 1940. Un dramma già raccontato in numerosi film e romanzi, per non parlare della vastissima saggistica al riguardo, ma onestamente mi pare che non sia mai stato trattato con lo stile, la precisione, la densità, la forza e il potere di suggestione messo in campo dall’autore cubano. Anche perché Padura non si limita a ripercorrere minuziosamente i penosissimi anni dell’esilio del leader rivoluzionario fino a quel fatale giorno d’agosto, né a ricostruire la vita e l’inquietante formazione nei servizi segreti stalinisti del suo assassino, Ramón Mercader del Río, ma lega perfettamente queste due vicende a una più personale e attuale, perfino più autobiografica, che si risolve, già da sola, in un meraviglioso romanzo di formazione: è la storia di Iván Cárdenas, ex aspirante scrittore e ora responsabile di un malandato studio veterinario all’Avana, che, incontrando sulla spiaggia un misterioso straniero accompagnato da due levrieri borzoi, scopre a poco a poco la storia di Trotskij, delle sue idee e del suo assassinio, censurati e dimenticati nella Cuba di Castro, aprendo gli occhi sull’oppressione e il genocidio in cui si è risolta una delle grandi utopie del XX secolo e sul venir meno di «tutte le promesse che gli avevano fatto in gioventù».
Costruito con una complessa architettura, con tre storie alternate che rimandano l’una all’altra, il romanzo riesce a trasformare anche le figure secondarie in personaggi dalla psicologia complessa, con inquietudini, passioni e debolezze. Ma è sui tre protagonisti che si concentra l’attenzione del lettore, trascinato al loro seguito da Barcellona a Mosca, da Oslo a Parigi, da Istanbul a Città del Messico, al ritmo incalzante dei drammatici eventi europei dagli anni Trenta fino alla guerra mondiale: gli intrighi di Stalin per eliminare amici e nemici, l’ascesa del nazismo, la guerra civile spagnola e gli orrori all’interno del fronte repubblicano, la grigia Mosca dei processi farsa agli oppositori del tiranno, il patto Molotov-Ribbentrop, la disintegrazione dell’Urss e le varie crisi cubane che decidono via via il destino di Trotskij, di Mercader e perfino di Iván Cárdenas. Tre uomini in uno: uomini diversi, certo, che tuttavia costituiscono una specie di Trinità circonfusa dal male del XX secolo, le ideologie totalitarie. Due di loro, Trotskij e soprattutto Mercader, sono stati dei fanatici, dei fondamentalisti, diremmo oggi, capaci di qualunque cosa in nome di un’idea, ma sono stati allo stesso tempo ingannati o traditi come il terzo, il povero e sfortunato Iván.
Straordinaria è, soprattutto, l’abilità di Padura di penetrare nella personalità di Mercader e nelle sue oblique ragioni. Il lettore sa che quell’uomo è, appunto, un fanatico, una bomba a orologeria creata dall’orrore staliniano, un assassino potenziale che non troverà pace fin quando non conficcherà la famosa piccozza nel cranio di Trotskij, continuando poi, per tutta la vita, a risentire nelle orecchie l’urlo lacerante della sua vittima. Ma è tale la capacità dell’autore di collocarlo nel suo ambiente e nel suo contesto storico, è talmente profonda la resa letteraria dei suoi pensieri e delle sue azioni, che alla fine non si può fare a meno di provare, come scrive lo stesso Cárdenas-Padura, «una mescolanza sibillina di repulsione e compassione (sì, compassione, e non ho mai avuto dubbi sulla parola né sul suo significato) per quel Mornard-Jacson-Mercader pronto a compiere quello che aveva accettato come il proprio dovere e, soprattutto, come una necessità storica imposta dal futuro dell’umanità». «Compassione» è, infatti, una parola che ricorre più e più volte nel romanzo. Non compare mai, invece, la parola «perdono», perché, secondo Padura, anche nel totalitarismo più ferreo, rimane sempre uno spiraglio etico a cui l’individuo può afferrarsi e che gli consente di dire di no all’inammissibile.