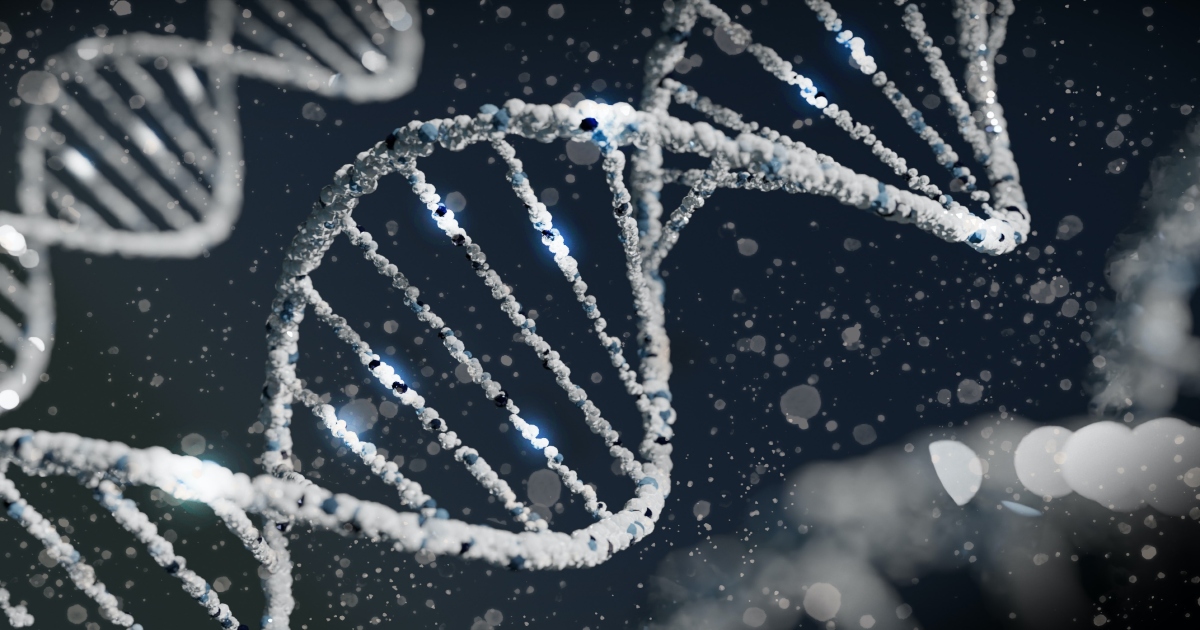
Foto: Sangharsh Lohakare/Unsplash
Ogni cellula eucariote, nel corso della sua vita, attraversa una serie di stadi, o fasi, che culminano nel processo di divisione cellulare. A regolare il corretto svolgimento delle fasi che compongono il ciclo cellulare sono alcuni geni, la cui identità e le cui funzioni sono state rivelate, grazie ai loro studi condotti a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, da Leland Hartwell, Paul Nurse e Tim Hunt, i tre vincitori del premio Nobel per la medicina nel 2001.
L’importanza delle scoperte che sono valse ai ricercatori il Nobel è sostanziale per diversi motivi. In primo luogo, comprendere i meccanismi che regolano il ciclo di riproduzione cellulare – e dunque la trasmissione del materiale genetico dalla cellula madre alle cellule figlie – apre la strada alla comprensione dell’origine delle alterazioni cromosomiche che sono spesso osservate nelle cellule tumorali. Inoltre, la straordinaria scoperta – fornita da Paul Nurse nel 1987 – della presenza degli stessi meccanismi in organismi così morfologicamente diversi ed evolutivamente lontani come i lieviti (l’organismo modello utilizzato da Nurse nei suoi esperimenti era Schizosaccharomices pombe) è un’importante, ulteriore conferma della validità della teoria evoluzionistica, che postula la comune origine di tutte le forme di vita e la loro successiva diversificazione per mezzo dell’azione combinata di agenti di variazione e selezione naturale.
Da una prospettiva evoluzionistica, a spiegare questa corrispondenza di geni che regolano il ciclo cellulare in organismi molto distanti gli uni dagli altri è la selezione naturale: è per via della selezione naturale, infatti, che questi geni sono stati fortemente conservati lungo tutta la storia di divergenza evolutiva successiva all’antichissima separazione tra organismi microscopici come i funghi, regno del quale i lieviti fanno parte, e gli antenati dei mammiferi.
Abbiamo incontrato Sir Paul Nurse, già direttore del dipartimento di microbiologia all’università di Oxford, rettore della Rockefeller University di New York, presidente della Royal Society dal 2010 al 2015 e, dal 2011, direttore del Francis Crick Institute di Londra.
L'intervista completa a Sir Paul Nurse. Servizio e riprese di Sofia Belardinelli, montaggio di Barbara Paknazar
Professor Nurse, le sue scoperte hanno implicazioni fondamentali sia in termini di ricerca di base, per comprendere come funziona il ciclo cellulare, sia in termini applicativi, come ad esempio per la ricerca sui tumori. Ma scoperte di tale portata possono sollevare anche domande teoriche, come quella che lei affronta nel suo libro “Che cos’è la vita?” (Mondadori 2021).
In che modo il suo lavoro come sperimentalista ha influito sul modo di affrontare temi teorici di così ampia portata?
«Per rispondere a questa domanda, credo di dover tornare molto indietro nel tempo, a quando ero uno studente di dottorato. Ero specializzato nello studio di piante e funghi. Fu durante quel periodo che mi resi conto che il problema più importante della biologia era capire cosa sia la vita. Iniziai così a riflettere su quali fossero le principali caratteristiche della vita: una certamente primaria è la riproduzione, dal momento che ogni essere vivente si riproduce. Decisi allora che dopo il mio dottorato mi sarei dedicato a questo fenomeno, studiandone la forma più semplice: la divisione della cellula in due. Non avrei potuto immaginare che avrei lavorato allo stesso argomento ancora cinquant’anni dopo.
Raccontare la mia storia mi permette di rispondere alla tua domanda: sì, sono uno sperimentalista, ma la mia ricerca è sempre stata mossa dall’intenzione di affrontare problemi fondamentali, che portano in sé numerose implicazioni teoretiche»
Una delle sue più importanti scoperte conferma l’affascinante fatto che ogni essere vivente, compresi gli esseri umani, è direttamente legato a tutti gli altri da una qualche relazione di ‘parentela’, che è manifesta anche nei fondamenti genetici della vita. Cosa significa questa consapevolezza?
«La mia ricerca mirava a capire il funzionamento dei meccanismi di riproduzione cellulare, e per i miei esperimenti utilizzavo un organismo molto semplice, un lievito. Una volta compreso a grandi linee il processo, scoprii l’insieme di geni coinvolti nella sua regolazione, i quali erano tutti collegati a un gene chiave, che abbiamo denominato CDK (Cyclin-Dependent-Kinase). A quel punto mi sono chiesto: è possibile che lo stesso meccanismo di regolazione sia presente anche negli esseri umani?
Tutto questo accadeva circa trent’anni fa: il sequenziamento completo del genoma umano era ancora di là da venire. Tuttavia, era da poco disponibile la prima “libreria” genetica umana, assemblata in America. Il genetista che l’aveva realizzata la condivise con noi, e io la utilizzai in questo modo: scelsi un lievito che, per via di una mutazione, non aveva il gene che gli avrebbe permesso di dividersi, e spruzzai su queste cellule – metaforicamente, s’intende! – i geni umani, pensando che, se vi fosse stata una corrispondenza tra i geni umani e quelli del lievito, con questa operazione il lievito mutante sarebbe stato ‘riparato’ e avrebbe cominciato a dividersi. Era un’ipotesi molto azzardata, e ci aspettavamo che l’esperimento non funzionasse: la divergenza evolutiva tra esseri umani e lieviti risale a un miliardo e cinquecento milioni di anni fa, un tempo immenso. Eppure, contro tutte le previsioni, l’esperimento funzionò.
Se la divisione cellulare può essere controllata allo stesso modo in organismi tanto lontani quanto un lievito e un umano, ciò significa che ogni essere vivente – ogni animale, ogni pianta, ogni fungo – devono allora condividere gli stessi meccanismi molecolari di divisione cellulare.
Quali potrebbero essere le implicazioni filosofiche? Be’, tutto questo dimostra in primo luogo che l’idea darwiniana di un albero della vita, con un unico gambo iniziale e sempre più ramificazioni e foglie sviluppate nel corso del tempo, che mostra che siamo tutti collegati, è vera.
Pensandoci, dunque, questo significa che, all’interno della biosfera, siamo completamente circondati da nostri parenti. E se noi umani siamo, in qualche modo, apice di questo lento processo evolutivo (non sono per nulla certo che sia così, ma fingiamo per un attimo che ciò sia vero), non abbiamo allora la responsabilità di prenderci cura di tutti questi nostri parenti?»
Lei è non solo scienziato, ma anche amministratore di istituzioni scientifiche. Considerando questa duplice esperienza, quale crede sia il ruolo della ricerca di base? La società ne riconosce adeguatamente l’importanza?
«Conviene pensare alla ricerca scientifica come a una sorta di spettro, che va dalla scoperta di nuove evidenze – quel che viene comunemente definito ‘ricerca di base’, ma che io preferisco chiamare ‘ricerca di scoperta’ – all’applicazione di esse per fini sociali ed economici.
Queste due dimensioni della scienza funzionano in modi decisamente diversi. Certo, condividono una serie di principi fondamentali: verità, trasparenza, eccetera. Ma il fatto che questi due tipi di ricerca vengono condotti in maniere differenti è spesso ignorato, soprattutto in ambito politico.
In altri termini, la ‘ricerca di scoperta’ dovrebbe essere lasciata libera, e bisognerebbe limitarsi ad incoraggiare gli scienziati a seguire la propria curiosità; la ricerca applicativa, al contrario, ha bisogno di direttive dall’alto, che definiscano i problemi più urgenti da affrontare con l’obiettivo di trovare soluzioni.
Provo ad esprimere questo bilanciamento dialettico con una metafora: se si sta costruendo un edificio e non si ha un budget illimitato, bisognerà decidere come investire le risorse. Se si spenderanno tutti i soldi per costruire l’edificio in altezza, ma non si investirà in fondamenta solide, la costruzione crollerà. Le fondamenta sono la ricerca di scoperta; la ricerca applicativa è l’altezza: per costruire un edificio servono entrambe. Ma se si proverà a incanalare la ricerca di scoperta, o a lasciare libera la ricerca applicativa, i risultati non ci saranno: serve l’intero spettro della scienza
Nel mondo reale, tuttavia, non è infrequente che i politici – non tutti, certo, ma molti – siano legati alle industrie, e che quindi abbiano interesse solo nella dimensione pratica, applicativa. Abbiamo bisogno di insegnare ai politici questa visione complessa della scienza, così che si tenga conto dell’intero spettro e non si costruisca un edificio del tutto privo di fondamenta».
Lei è noto anche per le proprie idee politiche: come scienziato, ha spesso espresso pubblicamente la propria opinione su temi di attualità. Che ruolo dovrebbe avere, a suo avviso, lo scienziato all’interno del dibattito pubblico?
«Gli scienziati hanno una responsabilità verso la società. La società ci sostiene, nella prospettiva che contribuiamo alla conoscenza collettiva. Questo sostegno non deve essere dato per scontato: come scienziati, dobbiamo sempre ricordare che facciamo parte della società e che siamo sovvenzionati da essa. Ecco perché credo sia giusto provare anche a comunicare il contributo che la scienza può offrire alla società, in termini di possibili applicazioni o di temi complessi che andrebbero discussi collettivamente.
In molti casi, i ricercatori non hanno le risposte ai problemi che la società deve affrontare, ma hanno conoscenze che potrebbero rivelarsi importanti per individuare soluzioni. Perciò, il ruolo dello scienziato consiste nell’identificare nodi potenzialmente rilevanti e contribuire ad aumentare la conoscenza in relazione ad essi, così che il dibattito collettivo possa essere informato e completo, e che si possano affrontare temi complessi in un modo più soddisfacente».
Lei ha spesso parlato del suo percorso accademico, costellato non solo di grandi successi, ma anche di fallimenti. Quali consigli darebbe a uno studente o un giovane ricercatore che volesse intraprendere la carriera della ricerca?
«Vorrei condividere qualcosa di personale. Non provengo da una famiglia ‘scientifica’, ma da una famiglia di lavoratori, all’interno della quale nessuno – tranne me – è andato a scuola dopo i 15 anni. Questo ha significato molto per me, perché mi sento vicino alle persone normali, e non ho vissuto nella torre d’avorio abitata da alcuni miei colleghi. Al tempo stesso, questa mia provenienza ha reso il mio percorso un po’ più difficile: spesso sono stato bocciato agli esami, più di una volta ho fallito il test d’ingresso all’università, e più tardi ho dovuto scontrarmi con la difficoltà nel trovare un lavoro. Tutto questo, però, mi ha insegnato ad essere resiliente: quando sei un ricercatore, devi sapere che fallirai spesso.
La prima cosa che dico ai miei studenti, che arrivano nel mio laboratorio senza esser mai stati bocciati in tutta la loro vita, è: “Entro un mese di lavoro qui, vi troverete a fallire in ciò che state facendo. Io sarò qui ad aiutarvi, ma voi dovrete accettare il fallimento”.
Questo è essenziale per imparare come funziona la realtà: la ricerca può essere dura. Ecco perché essere resilienti è importante, accanto alla curiosità – ma di quella abbiamo già parlato.
I giovani che pensano a intraprendere la ricerca scientifica devono essere consapevoli che sarà una strada difficile, ma che, con il giusto atteggiamento, i problemi e le difficoltà possono essere superate. Ed è un lavoro fantastico. Non si diventa ricchi, ma si è pagati per seguire la propria curiosità. Per questo, io mi sento enormemente privilegiato».




