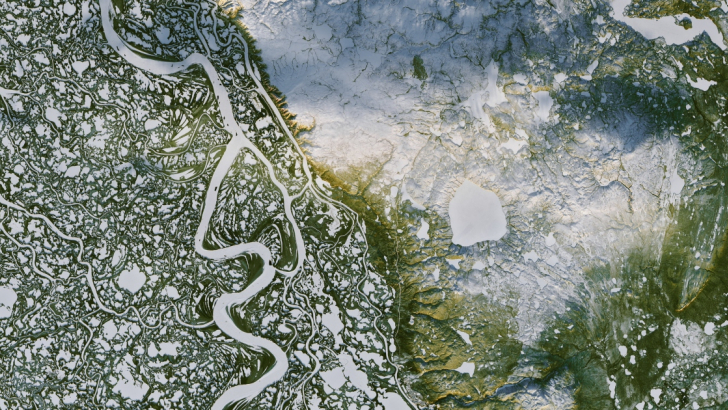Foto: Azzedine Rouichi/Unsplash
Secondo i dati raccolti da Ethnologue, oggi, nel mondo, esistono 7186 lingue vive. Circa la metà della popolazione mondiale parla solo 23 di queste lingue. Dal lato opposto dello spettro, invece, vi sono le lingue considerate “in pericolo” (endangered): sono 3045, circa il 40% del totale. Ma cosa significa che una lingua è in pericolo, e perché questo è rilevante?
Rivolgendosi ancora a Ethnologue, che è la pubblicazione più autorevole sul tema della diversità linguistica umana, si scopre che, per definizione, una lingua è considerata in pericolo quando «i parlanti iniziano ad utilizzare e ad insegnare ai bambini della propria comunità una lingua maggiormente dominante» rispetto alla propria lingua madre. Questo significa che, nel tempo, i parlanti “naturali” si riducono, e la trasmissione della conoscenza della lingua si dirada, fino a interrompersi. Nella maggior parte dei casi, questo è il destino riservato alle lingue indigene, che non sono istituzionalizzate (cioè, non sono utilizzate come lingue ufficiali da nessun organismo istituzionale) e la cui trasmissione intergenerazionale avviene soltanto in maniera informale, ad esempio attraverso l’utilizzo della lingua nel contesto familiare.
La perdita di lingue minoritarie non è un fenomeno nuovo. Fin dall’inizio dell’epoca coloniale europea, infatti, si è affermata la tendenza a penalizzare – intenzionalmente o meno – le lingue madri dei popoli indigeni colonizzati, il che ha portato, nel tempo, a una forte contrazione della diversità linguistica a livello mondiale.
Secondo una narrazione sviluppatasi in decenni recenti, e oggi molto diffusa, proteggere le lingue indigene, e in generale le lingue minoritarie, è importante per motivazioni etiche, sociali e politiche. Come ha affermato in un’intervista a Il Bo Live Matteo Santipolo, docente di didattica delle lingue moderne all'università di Padova, «Ogni lingua è veicolo di una diversa visione del mondo, la cosiddetta Weltanschauung. Quindi quando una lingua muore, muore anche una precisa visione del mondo. Perciò, a mio parere, le lingue andrebbero salvate e valorizzate proprio in questa prospettiva: ciascuna lingua è un patrimonio di valori e significati e talvolta, in termini più strettamente linguistici, di strutture, di fenomeni linguistici […] di enorme ricchezza».
Questa argomentazione è condivisa da molti studiosi. Non di rado, ad esempio, si paragonano le lingue alle specie di esseri viventi: in entrambi i casi si parla di diversità (linguistica in un caso, biologica nell’altro) e ad essa si riconosce un valore intrinseco; la scala di vulnerabilità applicata alle due dimensioni è simile (l’Atlas of the World’s Languages in Danger dell’UNESCO usa categorie che vanno da “sicuro” a “vulnerabile” a “in pericolo critico” di estinzione, che ricordano le categorie usate dalla IUCN, International Union for the Conservation of Nature); le lingue, come le specie viventi, sono sovente considerate entità a sé stanti.
Questa visione ha influenzato profondamente la progettazione di misure politiche per la protezione delle lingue minoritarie. In molti casi, infatti, l’attenzione è stata posta in modo quasi esclusivo sulla protezione della lingua in sé, in quanto patrimonio immateriale da tutelare. Quel che questo approccio trascura, tuttavia, è il ruolo che la lingua svolge all’interno del contesto sociale nel quale viene utilizzata: la lingua, infatti, è prima di tutto un mezzo di comunicazione utilizzato da una comunità di parlanti, e di questa segue fluidamente le dinamiche di evoluzione nel tempo. Da questa prospettiva, l’interpretazione della lingua come entità autonoma appare se non altro parziale, dal momento che tale visione non tiene in considerazione la dinamicità delle lingue umane, il loro essere in costante cambiamento.
In un articolo scientifico pubblicato sull’International Journal of Applied Linguistics e su un corrispondente commento comparso sulla rivista The Conversation, il linguista Dave Sayers, docente all’università di Jyväskylä, in Finlandia, avanza una riflessione che problematizza le politiche di protezione e promozione delle lingue minoritarie. La domanda centrale che Sayers si pone è la seguente: chi sono i veri beneficiari di iniziative politiche che valorizzano le lingue minoritarie e, in alcuni casi, ne promuovono attivamente la diffusione?
Una delle motivazioni che più frequentemente vengono addotte per giustificare politiche di protezione delle lingue minoritarie storicamente presenti sul territorio consiste nell’affermare che quelle lingue siano centrali per mantenere l’identità di singoli e comunità. A questo argomento, Sayers oppone il fatto che non necessariamente l’identità di una comunità è racchiusa nella lingua tradizionale. Al contrario, l’incontro con una lingua dominante può produrre nuove lingue minoritarie, altrettanto uniche al mondo, nelle quali alcune comunità potrebbero identificarsi.
Un altro tema molto ricorrente nel giustificare la rinnovata attenzione per le lingue tradizionali è quello che potremmo definire “riparatorio”: tutelare queste comunità linguistiche è ritenuto un risarcimento per i molteplici danni inflitti dal colonialismo. La domanda che, in questo caso, Sayers si pone è: «Certo, permettere a un popolo di usare la propria lingua tradizionale può contribuire a migliorare la condizione dei suoi utilizzatori. Ma li aiuta davvero?». Citando diversi studi condotti su popolazioni native, infatti, emerge che politiche che si limitano a promuovere l’utilizzo della lingua indigena non hanno alcun effetto sul benessere dei membri della comunità, come mostra ad esempio l’ininfluenza di questa misura sui tassi di suicidio, un indicatore centrale per determinare il benessere degli individui.
Intervenire su singoli elementi sperando che questo porti a cambiamenti trasversali è quanto meno ingenuo: «Limitarsi ad introdurre la lingua degli antenati tra le materie scolastiche non è di grande aiuto se la scuola è fatiscente, se non si ha accesso a una dieta sana, se una percentuale sproporzionata di persone della propria comunità è in carcere o se non si ha un’adeguata rappresentanza politica», afferma il linguista nell’articolo su The Conversation.
Se l’obiettivo di un intervento politico è quello di migliorare complessivamente le condizioni di vita di una comunità, è probabile che focalizzarsi su un singolo aspetto – in questo caso, la lingua – si riveli una strategia inefficace. «Nonostante sia difficile per un linguista ammetterlo – prosegue Sayers – forse bisognerebbe concentrarsi meno sulla protezione della lingua in sé, e più sui molteplici e interconnessi bisogni delle persone che le parlano».
Se l’obiettivo di un intervento politico è quello di migliorare complessivamente le condizioni di vita di una comunità, è probabile che focalizzarsi su un singolo aspetto – in questo caso, la lingua – si riveli una strategia inefficace. «Nonostante sia difficile per un linguista ammetterlo – prosegue Sayers – forse bisognerebbe concentrarsi meno sulla protezione della lingua in sé, e più sui molteplici e interconnessi bisogni delle persone che le parlano».
A tal proposito il ricercatore, nel suo articolo scientifico, propone una distribuzione delle politiche linguistiche esistenti all’interno di uno spettro ai cui due estremi si pongono, da un lato, le misure che si concentrano quasi esclusivamente sulle capacità esistenti e potenziali dei cittadini, e dall’altro quelle che hanno per obiettivo la tutela della lingua quale entità a sé stante.
Secondo la prospettiva dei “diritti umani linguistici” di cui è stata principale esponente la linguista Tove Skutnabb-Kangas, che si lega alla teoria delle capacità proposta dall’economista Amartya Sen, le politiche linguistiche dovrebbero essere strutturate in modo tale da assicurare che, in primo luogo, le persone e le comunità svantaggiate abbiano accesso a un’istruzione adeguata e abbiano gli strumenti per vivere la propria vita con le stesse capacità degli altri cittadini (votare, pianificare le proprie finanze, decidere della propria vita lavorativa e così via). In alcuni casi, questo obiettivo è raggiunto più facilmente privilegiando la diffusione della lingua dominante, a discapito, purtroppo, di quelle tradizionali e minoritarie. Ma, in un’ottica consequenzialista come quella descritta, la tutela della lingua non è l’obiettivo primario, ed è importante riconoscere che, in alcuni casi, imporre, ad esempio, la lingua dei propri ascendenti a bambini che non la parlano correntemente può essere fortemente controproducente per la loro crescita personale e per il loro inserimento nella società.
In questa scia – sottolinea ancora Sayers – si inserisce anche la teoria dell’“ingiustizia strutturale”, secondo cui «l’oppressione, all’interno della società, agisce su molti livelli interconnessi, e non può essere affrontata risolvendone soltanto uno in particolare». Questo è particolarmente evidente quando si progettano politiche linguistiche: una comunità, infatti, potrebbe essere unita sotto il profilo linguistico ma fratturata al suo interno dal punto di vista sociale, culturale politico o economico. Per migliorare il benessere all’interno di quella specifica comunità, dunque, è essenziale affrontare le varie criticità in modo congiunto.
A determinare la struttura e il successo di un intervento politico è dunque, a ben guardare, l’obiettivo che ci si propone di raggiungere: il dilemma, ben sintetizzato dal linguista, è tra “usare la lingua per aiutare le persone” o “usare le persone per proteggere la lingua”. Sayers sottolinea che, spesso, questi due scopi non si escludono a vicenda, ma coincidono. Bisogna però esserne consapevoli, per comprendere in che modo una determinata misura sociale può modificare gli equilibri all’interno di una comunità. È importante tenere in considerazione le questioni sollevate da teorie come quella dei diritti umani linguistici o dell’ingiustizia strutturale, abbandonando l’idea che le comunità minoritarie siano delle entità monolitiche e riconoscendo, piuttosto, che esse sono composte da individui, e che verso questi ultimi la politica deve dirigere i propri sforzi.