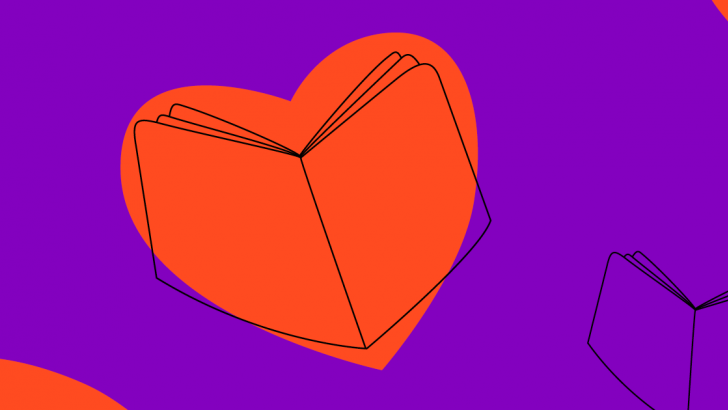Remo Rapino durante la cerimonia di premiazione. Foto: Premio Campiello
Vince la cinquantottesima edizione del Premio Campiello con suo grande stupore (lo definisce “un regalo inaspettato”) l’abruzzese Remo Rapino con Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio (minimum fax), la biografia quasi parlata di una “cocciamatte” (dal glossario che segue il romanzo: “testa pazza”) che, come dice l’autore stesso, “è un personaggio inventato ma i fatti della sua vita sono realmente accaduti”.
Non stupisce per nulla, invece, che il Campiello premi un libro (di un editore indipendente) che sotto molti aspetti si distanzia dalla letteratura main stream e in cui l’abilità dello scrittore produce ciò a cui qualunque narratore aspira: una voce potente. Stessa cosa accadeva l’anno scorso con Madrigale senza suono di Andrea Tarabbia e – chissà – quella di cercare testi straordinari, intesi come fuori dall’ordinario, potrebbe diventare forse la cifra del premio (peraltro Rapino era anche nella dozzina dello Strega).
Il romanzo ha di speciale soprattutto il modo di narrare ch’è uno stream of consciousness inedito, perché la testa in cui il lettore entra è quella di “Bonfiglio Liborio, senza né arte né parte e né madre né padre” che, come si dice nell’incipit, “tutti vanno dicendo che [è] matto”. Quello del protagonista è un racconto in retrospettiva dell’intera sua vita, fatto senza mai prendere fiato. Le frasi sono lunghe, scritte in una lingua che l’autore definisce “meticciata” (italiano, dialetto, parole che non si usano più e risalgono fin al Medioevo, neologismi – ad esempio “fiommista” per dire ch’era iscritto alla FIOM) in cui molte volte vengono ripetuti gli stessi concetti, proprio come accade nel discorso di un “matto”, che diventano così elementi cardine di quel racconto che lui fa per allungarsi la vita, come se, finché ha da scrivere, la morte non potesse sopraggiungere.
E, in effetti, il protagonista c’è stato per davvero in manicomio, anche se il dottor Mattolini Alvise (cognome e nome, Bonfiglio Liborio così chiama le persone – anche quella Giordani Teresa che ha amato da ragazzino ma che ha sposato un altro) gli dice sempre che pazzo lui proprio non pare, e, a ben vedere, il protagonista è molto più di questo: è stato soldato, ha lavorato come operaio al reparto macchine da cucire della ditta dei fratelli Borletti a Milano e poi alla Ducati di Bologna, iscritto al sindacato non ha mancato una manifestazione, lo hanno pure processato, si è occupato dell’amico sifilitico, e ha, a volte, compiuto quelle che lui chiama le “cattiverie rivoltose”, cioè azioni con cui in qualche modo riequilibrare “i segni neri”, le ingiustizie inferte a ciascuno dalla vita.
Remo Rapino racconta di aver voluto, attraverso il racconto della vita di Liborio, “dar voce agli emarginati, mostrare le crepe del mondo da una periferia esistenziale” inventando un personaggio “ch’è a cavallo tra Don Chisciotte e Forrest Gump e che affonda le radici nel fool shakespeariano”. E se da un lato “inventare una storia è meno complicato che inventarsi una lingua”, dall’altro quel racconto si rendeva per lui evidentemente necessario. “Parlare infatti – spiega – è una battaglia per tornare ad appartenersi”: vale in generale e ancor di più per tutti coloro che si trovano per qualche ragione fuori margine, e che sono usciti, prima che dalla sua penna, da quella (o nei progetti) anche di altri scrittori (i repertori di Roberto Alajmo e di Paolo Nori ne sono un esempio). Il continuo ripetere, quasi ossessivo, che Bonfiglio Liborio fa di concetti e modi di dire, se da un lato sembra il desiderio di affermare delle verità cui aggrapparsi (che lui ha gli occhi di suo padre, che però non ha mai conosciuto, tanto per dire), dall’altro è, come spiega l’autore, “per paura di non essere ascoltato”.
E sono i suoi stessi pensieri, che, in certi momenti della vita, Bonfiglio Liborio non sentiva più, coperti dai rumori della fabbrica che lo hanno portato alla “lienazione”: “bistanclaque bistanclaque bistanclaque, tata tatan tatatan, tutum tutum, tututum [che] erano solo un fatto pissicologico”.
“Perciò – aggiunge Rapino – Vita morte e miracoli è un libro politico nel senso etimologico del termine, legato cioè al concetto di pòlis e di comunità: un romanzo che vuole passare dall’io al noi”. Moltissimi degli episodi raccontati sono davvero successi, a persone vicine all’autore (suo padre è nato nel 1926 e morto nel 2010, come Liborio; la figura del maestro Cianfarra Romeo ricalca quella del suo di maestro, ecc.) o nella Storia (uno dei capitoli iniziali – che l’autore dice “andrebbe letto col fiato grosso, correndo” – racconta la vicenda dei martiri ottobrini di Lanciano, quei partigiani che il 5 e 6 ottobre del ’43 affrontarono i tedeschi).
Il punto di vista naïf di un cosiddetto matto, peraltro, permette a Rapino una estrema libertà di espressione e di dire più e più volte che il re è nudo e di dirlo con estrema semplicità, come quando spiega la differenza tra i “giovanotti vestiti tutti uguali con i blugins e le camicie colorate” e “quelli più anziani, che invece erano vestiti normale [con cui] s’appiccavano”: […] dopo un poco ho capito che quelli con i blugins erano stremisti e quelli vestiti normali erano comunisti”.
Nel procedere tra le pagine più volte il lettore si troverà il sorriso sulle labbra, pur nell’apprendere verità scomode o dolorose, “perché – spiega l’autore – volevo fare un’opera divertente, in senso etimologico, cioè che possa anche divertere dalle cose che hanno un senso precostituito”.