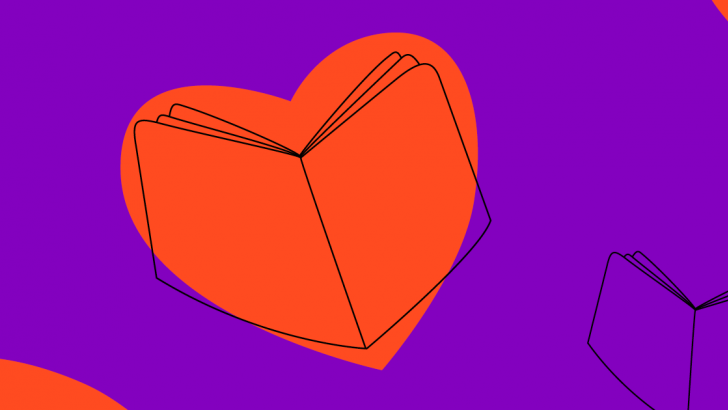Alberto Garlini, curatore artistico di Pordenonelegge e autore di diversi romanzi tra cui Il canto dell'ippopotamo in cui ricorda la vita dell'amico e poeta Pierluigi Cappello, è in libreria con un nuovo romanzo, Il sole senza ombra, per Mondadori. Ne proponiamo un estratto (dal capitolo 16) e l'intervista video allo scrittore.
Giugno 1978-febbraio 1979
Verso la fine di giugno Elmo ci annunciò che si sarebbe sposato in autunno. Betta non era d’accordo, le sembrava una scelta prematura, ma, se lo aiutava nella creatività, lo avrebbe accontentato. Quel matrimonio improvvisato non ci stupì più di tanto, si intonava perfettamente all’assurdità del periodo. Non avevo mai visto Elmo così astratto dal resto della gente. Aveva rinunciato alle prove in via Stalingrado, quando ci vedevamo non parlava più di progetti, di spettacoli, di risate. Leggeva molto, questo sì – teatro nordico, romanzi sudamericani, giornali e settimanali dalla prima all’ultima pagina –, ma se stava davvero raccogliendo materiale per il monologo su Moro, con costanza e determinazione, come ebbe poi a sostenere, lo faceva con una bassa intensità che si avvicinava all’apatia. Aveva comprato dei quaderni rossi, marca Pigna, e fingeva di prendere appunti. Come un santo mistico, viveva nella parte oscura delle sue contraddizioni.
Una sera che Betta era a Parma, per dare un esame o chissà cosa, andammo a vedere La grande estasi dell’intagliatore Steiner di Werner Herzog. In macchina, Elmo si mise a parlare di cinema. Il discorso girava intorno alla luce azzurrina della proiezione, al cono slavato, particellare, solcato da fumo e polvere brillante. Ogni film andava interpretato come una parodia della realtà, un conflitto tra noi e la nostra immaginazione. E questo conflitto ciondolava di bocca in bocca, in forma di stupore, tra gente che non era disposta a rischiare.
«Rischiare cosa?» gli chiese Rossella. Conoscevo quell’intonazione: da grafico piatto, quasi fossile.
Dovevamo ancora comprare i biglietti.
«Di vivere la vita, perché...»
«Piantala, ti prego» lo fermò.
«Per una sera basta bugie.» Elmo tentò di aprire bocca.
«Se provi a dire “ma infatti” ti strangolo.»
Rossella si eclissò, mescolandosi alle persone davanti al banco dove veniva versato vino nei bicchieri di plastica. Dalla sala provenivano dei rimbombi, spostavano le sedie o qualcosa di più pesante. Un ragazzo con la camicia bianca era appoggiato al manifesto di un film di Tarkovskij. Elmo mi chiese di colpo se volevo dei figli da Rossella. Non risposi. I figli sono belli, insisteva, ma sono una scelta impegnativa. Magari all’inizio si pensa di farli per amore, dopo le cose cambiano. Nessun figlio è veramente figlio dell’amore, aggiunse, fare un figlio è come frugare in un armadio alla ricerca di se stessi. E poi ci si lamenta se quello che si trova fa schifo. Gli diedi dello stronzo, se non ricordo male. Forse perché non mi veniva altro da dire. Un tipo barbuto ci fece cenno di entrare. Le luci si spensero, il chiacchiericcio scemò in sussurro attento, la polvere scintillò nell’aria.
Il film, una specie di documentario lirico, aveva come protagonista il campione del mondo di salto con gli sci, Walter Steiner. Un atleta che si ergeva talmente al di sopra degli altri, e volava talmente alto e lungo nel cielo, che a ogni salto rischiava la vita. Planava quasi alla fine della pista, sul piatto, dove non c’era modo di attutire l’urto. Herzog riprendeva i salti rallentando le immagini e velocizzandole di colpo. Nel film si vedeva quest’uomo, solo, nel cielo nebbioso, slanciato in una posizione perfetta, una specie di corpo trasfigurato sempre in procinto di scomparire tra le nuvole, che poi cadeva a terra e si rovinava il volto e le mani, e sanguinava ed era costretto a risalire alla sua pelle, ai suoi muscoli allungati, perfino al sangue, dopo essersi scarnificato nel volo. Steiner era un solitario, aspirava alla purezza del volo, a nient’altro, e quando non volava intagliava il legno, si estraniava dal mondo, ancora una volta, per ricrearlo con delicate sottrazioni. Il documentario era commovente, la solitudine e la bellezza di quel campione così al di sopra degli altri toccavano il cuore come può toccarlo l’esplorazione di un limite sconosciuto che non sarà mai nostro, ma che sappiamo agitarsi in noi. Terminava con un rallenti estenuato di Steiner in volo, sempre in procinto di lasciare il corpo per diventare aria, o cielo, o vuoto, o forma pura del nostro passaggio terreno, forma assurda fragile bellissima. In sovrimpressione le parole di una poesia di Robert Walser che Steiner recitava con una voce interiore, la voce del suo silenzio: “Dovrei essere solo al mondo, io e nessun’altra forma di vita. Niente sole, niente cultura, io nudo sopra un’alta roccia, senza tempeste, senza neve, senza banche, senza soldi, senza tempo e senza respiro. Allora di sicuro non avrei più paura”.
Era ancora buio quando Elmo si alzò dalla sedia, visibilmente alterato. Andò davanti allo schermo, nella luce azzurrina e slavata, tra la polvere scintillante, mentre ancora le immagini del saltatore scorrevano e il corpo si confondeva con l’aria. Urlando sopra la musica estenuata dei titoli di coda, tentò di impostare una routine comica che capivo e non capivo. Forse una serie di giochi di parole sul salto con gli sci e il salto della quaglia, cioè l’artigianale metodo contraccettivo che allora si usava negli incontri occasionali: uscire giusto in tempo, prima di, estrarre lo spadone dal fodero, risparmiare sul preservativo. «Bisogna usarlo solo con le donne, però» urlava. «Con gli uomini non serve. Gli uomini non hanno l’utero, hanno il culo. Viva il sesso tra uomini perché non serve saltare come una quaglia o un saltatore di sci!» Ma non faceva ridere, quel monologo, lo ricordo bene, era patetico. E ancora più patetico diventò quando le luci si riaccesero. Elmo rimase con le sue parole disarmate al centro della scena, nei bagliori clinici dei neon. Intrecciò le braccia al petto, gridò che qualcosa profumava di dattero e mandarino, non ricordo cosa, e cominciò a piangere. I ragazzi del collettivo lo guardavano un po’ esterrefatti un po’ confusi, mentre gli spettatori se ne andavano senza voltarsi, e io per primo me ne sarei andato e l’avrei lasciato lì a finire le sue lacrime. L’unica a reagire fu Rossella. Allo stesso modo di quando si era lanciata contro la polizia che assediava Radio Meraviglia, la vidi sganciarsi dalla folla con la medesima cupa determinazione e poi abbassarsi verso Elmo. Gli raccolse la testa fra le mani, gli baciò la fronte e gli occhi. Portò la guancia al seno.
Elmo si riprese velocemente, andò in bagno, si sciacquò la faccia e uscì come nuovo. Anzi: negò l’accaduto. Disse che era stato uno scherzo. Voleva provare una crisi di nervi, e cosa c’era di meglio che un pubblico vero, e per giunta colto di sorpresa? Elencò i comici che avevano unito crolli nervosi e comicità. Poi si soffermò su un solo nome, Lenny Bruce, e parlò dei suoi spettacoli da drogato, quando usciva dal camerino in accappatoio e sparava battute che nessuno capiva. Ecco il comico che sarebbe servito all’Italia contemporanea. Un comico sull’orlo di una crisi di nervi, come sull’orlo di una crisi di nervi era il nostro Paese. Si affannò così tanto in quell’opera di persuasione che finimmo per credergli. Nel frattempo Betta era tornata. La trovammo in piazza Verdi e la serata si concluse con una festicciola. Elmo e Brico cantarono i grandi successi dei Nomadi, a modo loro, non serve sottolinearlo.
Per celebrare il matrimonio scelsero Orgia, un paesino della provincia senese. In mezzo a una specie di bosco morto, in collina. La madre di Betta veniva da lì, da quello stupido paesello, così dissero, ed era morta giovane. Betta voleva rinverdire i fasti del matrimonio dei genitori, che era stato breve e infelice. Del resto non aveva invitato suo padre. A dirla tutta non aveva invitato nessuno, nessun parente e nessun amico, tranne una ragazza bruttarella, che si ubriacò velocemente e la perdemmo di vista agli antipasti. Forse Betta si vergognava del suo matrimonio, forse lo voleva tenere nascosto al padre possessivo. Forse aveva davvero accettato la proposta a scopo umanitario, salvare un artista dalla dissoluzione. Anche se ne dubito. Era calcolatrice e determinata. Le piaceva vivere, vivere bene, non le sciacquature del piacere, ma proprio il piacere. Secondo me già allora aveva calcolato la valanga di milioni con cui se ne sarebbe andata sette anni dopo.
Raggiungemmo la Toscana in auto; e una colonna di macchine scassate, tra cui una Visa con un adesivo della marijuana sul cofano, non passava di certo inosservata. Per strada ci fermò la polizia. Elmo tentò di protestare, ma non lo ascoltarono. Controllarono sotto i sedili dell’Alfasud alla ricerca di droga, bombe o volantini terroristici. Elmo sbatté la testa contro il finestrino per la disperazione, e chissà se era vera; e per essersi dimenticato l’anello a Bologna, e chissà se esisteva davvero quell’anello. La chiesetta medioevale era arroccata tra casupole del Quattrocento. La vedevamo apparire e scomparire lungo i tornanti. Proprio davanti a quell’altare la madre di Betta aveva fatto voto di non sposarsi se il fratello si fosse salvato da una rara malattia autoimmune, poi il fratello era morto e lei s’era sposata. Una storia un po’ ridicola, a pensarci adesso. Credo che a Elmo piacesse vedere la sua banda di amici spiantati occupare le navate di pietra. Quel posto era così lontano da noi, così mistico, raccolto, frugale, che ci sentivamo come degli spermatozoi di cane che ingravidano una principessa. La cerimonia fu tradizionale, tranne il sangue che colava dalla fronte di Elmo, e il fazzoletto di carta appiccicato per cercare di tamponarlo. Il prete era giovane, un prete operaio, sarebbe tornato in fabbrica dopo l’ufficio, aveva il turno del pomeriggio. Parlò dei legami degli uomini di fronte a dio, dell’indissolubilità delle relazioni, quando sono toccate dall’ala infuocata del divino. Una cosa del genere. Non ricordo bene. Probabilmente scemenze.
Era una bella giornata, luminosa, ma quando uscimmo venne un acquazzone improvviso, una bomba d’acqua, e ci trovammo addossati al muro a ridere e bagnarci, mentre i fiori bianchi delle decorazioni si spargevano al vento e appassivano a vista d’occhio. Il piombo delle nubi digradò in giallo malato e poi in bianco sporco, e infine l’azzurro dilavato del cielo riprese il suo posto. Quando venne il momento delle fotografie ci vergognammo come ladri. Io avevo dei jeans strappati in due punti, le scarpe infangate, Pippo una tuta rossa da vigile del fuoco, Antonio non si lavava i capelli da quindici giorni. Solo Rossella era vestita bene, con quel suo abito turchese dai risvolti dorati che la faceva brillare come una santa di Giotto. Elmo scappò via al momento dello scatto, lo vedemmo scomparire dietro una siepe. Pensammo che fosse impazzito. Uscì dall’intrico degli arbusti con un serpente in mano e un sorriso smagliante e colpevole. Aveva notato il serpente strisciare sul prato e non aveva resistito. Se la storia mitica di Adamo ed Eva si ripeteva intatta a ogni matrimonio, disse, allora il serpente era un simbolo, e doveva essere catturato. Mentre andavamo al casolare affittato per il pranzo di nozze vidi il braccio di Elmo uscire dall’auto davanti a me. Brandiva il serpente come un trofeo. Doveva essere ancora vivo, si agitava parecchio, o forse era la spinta dell’aria. Di tutto il cibo portato da Bologna – salami, formaggi, tortellini e una mortadella quasi intera, frutto di tre espropri proletari –, Elmo mangiò un paio di mele. Non voleva uscire dalla metafora biblica, disse. Tutti risero.
A me importava poco delle sue metafore, e perfino di lui, della sua commozione e degli occhi lucidi. Avevo bevuto parecchio, avevo cantato e ballato, e poi avevo trovato Rossella in una stanza, nella smorta luce di un cero, con un ago nella vena.