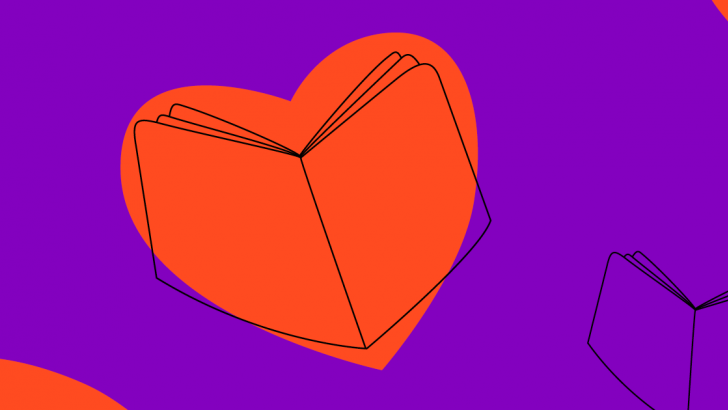Peter Handke durante la sua Nobel Lecture. Foto: Alexander Mahmoud © Nobel Media
Sono passati pochi giorni dalla cerimonia a Stoccolma, ma non si placano le polemiche intorno all’assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Peter Handke. Dopo il premier albanese e quello kosovaro, persino il Recep Tayyip Erdogan si è schierato con decisione contro l’assegnazione della prestigiosa onorificenza allo scrittore. Il presidente della Repubblica turca – dove dopo oltre un secolo continua a essere un crimine parlare del genocidio armeno – il 10 dicembre ha dichiarato che premiare “un razzista che nega il genocidio in Bosnia Erzegovina e difende i criminali di guerra equivale a premiare le violazioni dei diritti umani”.
Al fondo un problema tutt’altro che nuovo: in che misura bisogna tenere le opinioni di un artista o di un intellettuale nel giudicare la sua opera? E poi: in che misura è lecito e rispettabile difendere un regime come quello di Slobodan Milošević, condannato in diverse sedi politiche e giudiziarie per la repressione dei diritti umani? Questioni non facili, complicate dal fatto che Handke ha usato la sua stessa opera e il suo prestigio da intellettuale per diffondere e difendere le sue idee. Ma la vicenda del Nobel ad Handke solleva anche il problema della memoria storica in un territorio che, come i Balcani, è ancora oggi punto di contatto e spesso anche di scontro tra culture e religioni.
Never thought would feel to vomit because of a @NobelPrize but shamelessnes is becoming the normal part of the world we live🤮After disgraceful choice made from a moral authority like the Nobel Academy shame is sealed as a new value👎NO we can’t become so numb to racism&genocide!
— Edi Rama (@ediramaal) October 10, 2019
“Sono rimasto anch’io sorpreso, anche se sul fatto che sia un grande scrittore penso siamo tutti d’accordo – è il commento di Egidio Ivetic, docente di storia moderna e di storia dell’Europa orientale presso l’università di Padova –. Per la verità Handke non si è fatto molto sentire durante le fasi iniziali conflitto nell’ex Jugoslavia, tra il 1991 e il 1995; poi però ha scritto questo saggio, Un viaggio d'inverno ai fiumi Danubio, Sava, Morava e Drina ovvero Giustizia per la Serbia, e come altri intellettuali (penso ad esempio a Bernard-Henri Lévy) si è schierato dalla parte della Serbia, dandole in seguito supporto anche durante i bombardamenti della Nato nel 1999. Infine ha partecipato ai funerali di Milosevic, anche se disse che per lui significava partecipare ai funerali della Jugoslavia”. Una posizione che si lega direttamente al vissuto dello scrittore: “La madre è slovena ma lui sembra essere attaccato soprattutto alla repubblica di Tito, più che a quello che venuto dopo”. Una visione nostalgica e viscerale che forse gli ha impedito di capire che la terza Jugoslavia, quella di Milosevic, era ben diversa da quella di Tito, e che su di essa pesavano le vicende della guerra in Bosnia e soprattutto l’eccidio di Srebrenica.
“Siamo sei repubbliche – veniva fatto recitare nel dopoguerra nelle scuole – cinque nazioni, quattro lingue, tre religioni, due alfabeti”. E, naturalmente, “un solo Tito”. Un senso di nostalgia e di rimpianto non è raro nei Paesi ex comunisti (basti pensare a film come Goodbye Lenin e Underground di Emir Kusturica), ma nei Balcani si tinge di tinte particolari, mischiandosi al ricordo dei conflitti e degli eccidi che sono seguiti alla scomparsa di una federazione grande e indipendente, che per quasi quarant’anni sembrò assicurare pace e stabilità in una terra martoriata. Un sogno affogato nel sangue dopo la riscoperta negli anni ‘90 dei nazionalismi e dei fondamentalismi religiosi.

Milošević durante la firma degli Accordi di Dayton (14 dicembre 1995), assieme al presidente bosniaco Izetbegovic e a quello croato Tudjman. Foto: U.S. Air Force/Brian Schlumbohm
Un gioco al massacro dove spesso è difficile adottare la logica dei buoni contro i cattivi. “Nel caso della Jugoslavia era evidente che solo il comunismo era capace di tenere in piedi l’impalcatura dello stato e della convivenza civile tra i popoli, dopo gli eccidi della seconda guerra mondiale”, prosegue Egidio Ivetic, che al tema ha dedicato diversi libri tra cui I Balcani dopo i Balcani, Salerno 2016. Una Jugoslavia socialista nata dal mito della resistenza, unico Paese capace di cacciare gli invasori nazifascisti senza bisogno di aiuti esterni. “Anche se a dare una grossa mano ai partigiani titini fu soprattutto il nostro 8 settembre. Il disfacimento dell’esercito italiano praticamente li salvò, permettendogli di impossessarsi di buona parte del materiale bellico italiano: è nel novembre del 1943 che infatti viene proclamata la seconda Jugoslava, dopo quella monarchica uscita dalla prima guerra mondiale. Il regime monopartitico era una garanzia per andare oltre, ma con la fine del comunismo tornarono gli orrori sospesi nel 1945”.
Oggi sono passati quasi due anni dal 31 dicembre 2017, quando fu sciolto il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. “Sembrava essersi chiuso un ciclo, ma in realtà tutti i problemi sono ancora aperti – conclude Ivetic –. Restano da definire lo status del Kosovo, quello della Macedonia del nord con la sua comunità albanese e la questione bosniaca. C’è poi nell’area una presenza costante della Turchia con le sue mire neoottomane, a cui si aggiunge il tradizionale ruolo dei russi e una crescita incredibile dell’influenza dei cinesi. Persino i sauditi sono della partita, con il serbocroato che ormai è la terza lingua di Al Jazeera”. Una situazione policentrica e talvolta instabile, che sembra aspettare solo l’innesco giusto per esplodere, oggi come 100 anni fa, 30 anni fa. “Per questo in un certo senso il fantasma di Milosevic è ancora vivo e presente, e le stesse reazioni all’assegnazione del Nobel ad Handke lo dimostrano”.