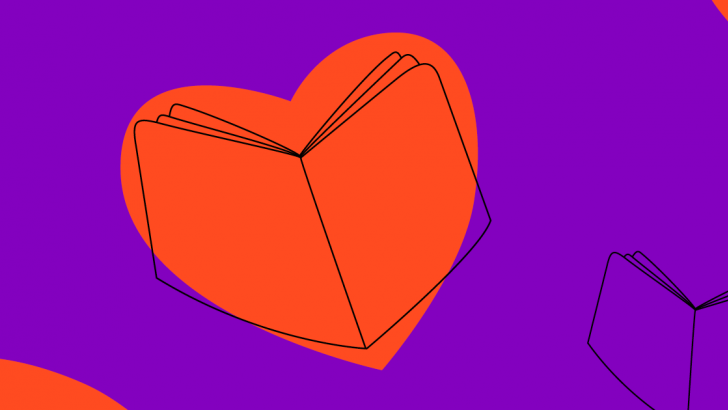Quest’autunno diversi scrittori italiani di fama sono usciti in libreria, per editori importanti, con romanzi in diversa misura autobiografici. Si parla tecnicamente di “autofiction”, termine usato per la prima volta nel 1977 dallo scrittore francese Serge Doubrovsky per un suo libro di cui era protagonista.
La letteratura italiana da molto tempo viene tacciata di essere “ombelicale” cioè di abusare di quest’approccio: di raccontare (solo) ciò che sai e ciò che sei (cosa che peraltro viene anche teorizzata in alcune scuole di scrittura creativa) e una domanda che gli autori in generale accolgono malvolentieri è proprio: “Quanto è autobiografico il tuo romanzo?”.
Se provate a farla, vi sentirete rispondere, con molto garbo, sostanzialmente che la risposta non ha minimamente importanza.
Paolo Giordano, Marco Missiroli e Yari Selvetella, solo per citare tre autori molto conosciuti del nostro panorama editoriale, hanno di recente dato alla luce romanzi in cui il dato autobiografico non è assolutamente trascurabile. Ma cosa cambia?
Sapere che il protagonista di Tasmania è P.G., le cui iniziali del nome coincidono, appunto, con quelle dell’autore modifica l’esperienza del lettore? Sapere che Claudio Prizio condivide con Yari Selvetella la forma geometrica della famiglia (due figli ereditati dalla precedente relazione che la compagna aveva avuto con altri uomini, un figlio messo al mondo con lei e una figlia dall’attuale fidanzata), che fa un mestiere come il suo e vive dove vive lui rende in qualche modo più credibile (o meno, poco importa) quello che leggiamo? Se il padre di Marco Missiroli è ancora vivo, o se lui stesso sia stato un giocatore d’azzardo può davvero influenzare quello che leggiamo?
Javier Marías, maestro nell’indagare il rapporto tra realtà e finzione, misurandolo nei suoi romanzi, scriveva: “Riferire l’accaduto è inconcepibile e vano, o è piuttosto possibile soltanto come invenzione”.
Quindi, per assurdo, si potrebbe teorizzare che sia la finzione a regalare gradi verità alla realtà. Alle volte, infatti, se si prova a mettere sulla pagina qualcosa che è successo davvero, questo risulta “debole” quasi fosse malamente inventato: lo sanno bene gli esordienti e i loro editor che spesso si trovano a dover spiegare loro il fenomeno.
Il rapporto realtà-finzione è cioè molto stretto e complesso, fortemente non lineare. C’è molto di autobiografico, di contro, in romanzi totalmente inventati: ambientati in un’altra epoca, tempo e che raccontano mestieri e mondi lontani a quelli di chi scrive.
Il processo messo in atto dallo scrittore è sempre lo stesso: guardare all’uomo e raccontarlo. “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, scriveva Plauto nel 165 a.C. e ci si può rendere conto con facilità (se si ha occasione di entrare in contatto con loro) che gli scrittori e le scrittrici sono profondi conoscitori delle dinamiche relazionali e psicologiche degli uomini e delle donne.
La disamina del confine tra realtà, finzione e verità è un nodo d’interesse anche per altre forme d’arte. Prendiamo ad esempio Roland Barthes, saggista, linguista e profondo conoscitore della fotografia: lui lo analizzava ne La camera chiara a proposito della foto analogica. Lì sostiene, infatti, che la fotografia sia il mezzo che permette di evidenziare la differenza sostanziale tra realtà e verità. I due concetti non vanno confusi: ciò che è reale può non essere necessariamente vero, o corrispondente a verità. In altre parole, anche una menzogna o una messa in scena ingannevole sono comunque entità reali, perlomeno nel momento in cui viene scattata la fotografia che le ritrae. La foto non testimonia tanto “ciò che non è più” ma testimonia senza ombra di dubbio “ciò che è stato”, perché si è trovato di fronte all’obiettivo. Barthes lo chiama “il referente” fotografico, cioè la cosa necessariamente reale, senza la quale la fotografia non avrebbe un contenuto.
A differenza della fotografia, la pittura o la parola possono anche simulare una realtà senza averla mai vista, dice. Si tratta di imitazioni della realtà (non per questo meno potenti e significative). Ma solo per la fotografia c'è la certezza che il referente in questione “sia stato là”, seppure poi rimosso per seguire il suo destino. I libri possono quindi inventare senza avere un referente che fisicamente sia esistito. E se, invece, è esistito, questo non cambia la natura del risultato.
Ecco quindi che quando Yari Selvetella ci porta nella sua vita (è la sua vita?) raccontandoci di un uomo che dubita di saper amare non sta parlando di sé, ma di quell’uomo, di noi.
LEGGI ANCHE: