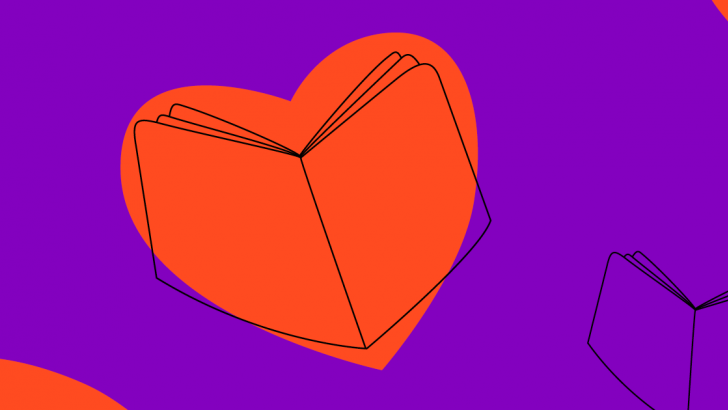Jonathan Franzen è tornato in libreria un uno dei suoi soliti “tomi”. Dopo il celeberrimo Le correzioni che vent’anni fa lo ha letteralmente consacrato, negli USA come nel resto del mondo, a scrittore universale, sono seguiti Libertà e Purity – romanzi impegnativi, in termini di lunghezza (superano tutti le 600 pagine), ma soprattutto per temi, atmosfera e personaggi–. Non è da meno Crossroads (Einaudi, 629 pagine) in cui l’autore per molti versi ritrova la cupezza dei precedenti (Franzen è tutto meno che consolatorio) ma con un rinnovato spirito di ricerca.
Anche in questa sua ultima fatica, come ne Le correzioni, si racconta una storia di famiglia, stavolta ambientata negli anni Settanta: quella di Marion e Russ e dei loro figli Clem, Becky Perry e Judson Hildebrandt. Di nuovo nessuno sta bene (e chi sta davvero bene? ci si potrebbe chiedere), con gli altri (anche se vige un’apparente normalità) e con se stesso, e chi legge cerca più volte un sollievo che Franzen – mai – darà.
È la sua cifra. La si coglie nello sguardo con cui ciascun personaggio vede il mondo e il proprio esistere in riferimento al destino che gli tocca in sorte, ma la si percepisce anche nel periodare dell’autore che racconta in una terza persona tutto fuorché onnisciente, anzi così annidata nel cuore tumultuoso e stretto di ciascuno da rendere davvero l’esperienza di immersione nel mondo che racconta a tratti disturbante. Non sono frasi mai semplici quelle che sceglie, ma ragionamenti articolati, complicati, in cui il significato primo ne cela dietro diversi altri ed è come se l’autore avesse bisogno di seminare il senso complessivo poco per volta, e forse per questo ha una misura lunga: nulla, davvero nulla, è mai spiegato.
Se poi le contraddizioni incarnate da ciascuno sono quelle che potrebbero imbarazzare la coscienza di chiunque anche oggi (il tradimento, cosa fare di un’eredità avuta in sorte che per senso di giustizia andrebbe condivisa, ma anche decidere di abortire, di drogarsi, di mentire, lasciare le cose in sospeso), a quel tempo e in quel contesto (Russ è un pastore ortodosso che conduce un “gregge” di giovani – Crossroads appunto –) Dio e la morale hanno un peso determinante sulle azioni e i cortocircuiti interni dei personaggi. In questo senso l’autore ha scritto un vero e proprio romanzo storico, non solo in termini di traslitterazione temporale, ma soprattutto di emersione di una mentalità, che si compone come un mosaico tra il presente e il passato di Russ (pavido?), Marion (personaggio femminile dalla sofferenza – e così dal fascino – incontestabili), Becky (viziata ma forse la più contemporanea), Clem (disposto a tutto, vuole persino arruolarsi per andare in Vietnam), Perry (che cede alla droga) e Judson (il piccolo di casa).
Degli esempi più generali? La contrapposizione tra bene e male o colpa e merito, tra giuramento e tradimento della parola data, e poi ancora tra volontà e cedimento, presente e passato sono tutti tranelli dentro i quali i personaggi della storia cadono senza possibilità di redenzione. Verrebbe di dire che Franzen non ne ami una di queste sue creature, o forse le ama come quel Dio cui nell’opera si fa continuamente riferimento ma che suona all’orecchio di chi ascolta come un immenso, e quantomai attuale, interrogativo.
Ecco perché Crossroads è una grande opera e Franzen si dimostra, ancora una volta, un autore pazzesco, pittore di chiaroscuri come Caravaggio. A cui non importa, per inciso, di compiacere il suo lettore: le prime pagine vanno lette più volte per entrare nella storia e c’è chi direbbe che è lento. Arrivati alla fine, poi, a differenza di Purity e Libertà che erano cerchi perfetti, ci sfida nuovamente: il romanzo “non finisce”. L’autore fa infatti sapere (ma non sulla pagina) che è solo il primo della trilogia degli Hildebrandt. Attenderemo.
Abbiamo intervistato la sua traduttrice storica, Silvia Pareschi: