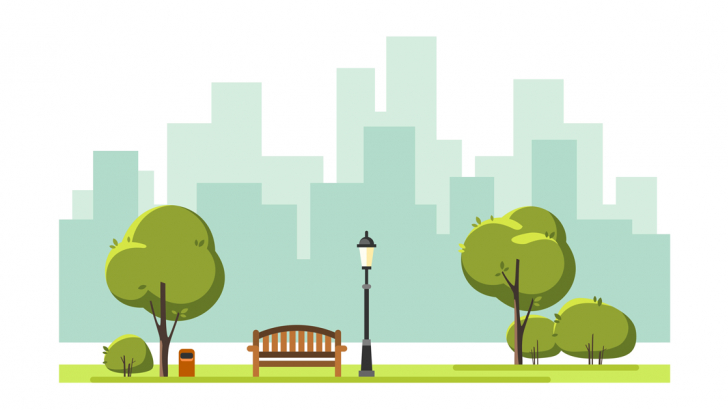SOCIETÀ
La città dopo la pandemia: traiamo le conclusioni

Si conclude la serie-dibattito “La città dopo la pandemia” pubblicata su Il Bo Live, il magazine online dell’Università di Padova, costituita dai contributi scritti da studiosi di vari ambiti scientifici, da noi invitati al dibattito che lanciammo oltre un anno fa sul tema del futuro della città dopo la pandemia da Covid-19. Noi, Cristoforo Sergio Bertuglia e Franco Vaio, curatori della serie-dibattito online, desideriamo rivolgere il nostro ringraziamento a tutti gli studiosi che hanno voluto partecipare con i loro contributi, così come desideriamo ringraziare il Prof. Telmo Pievani, direttore di Il Bo Live, per aver accolto la nostra proposta di pubblicare la serie sulla testata da lui diretta, e Elisabetta Tola per averci gentilmente ospitato sulla piattaforma di Il Bo Live di cui è caporedattrice. Un ringraziamento particolare va a Mattia Sopelsa per il lavoro redazionale di cui si è generosamente fatto carico, puntualmente svolto durante tutti i mesi in cui la serie è stata pubblicata, e per i numerosi consigli e suggerimenti che ci ha rivolto nel corso di questi mesi, di cui abbiamo fatto tesoro. Un ringraziamento e un carissimo ricordo sono rivolti alla memoria dell’amico Pietro Greco, scomparso da quasi un anno, che ci sostenne e incoraggiò con generoso entusiasmo fin dall’inizio, quando, eravamo ancora nell’estate del 2020, poche settimane dopo la fine del primo lockdown ‘duro’, lo rendemmo partecipe dell’idea che stavamo coltivando: quella di dare vita a un dibattito pubblico fra studiosi sull’incerto futuro della città, messa a dura prova, sotto molti punti di vista, dalla pandemia da Covid-19; un dibattito che intendevamo da svolgersi su una rivista che non fosse rivolta ai soli ‘addetti ai lavori’, specialisti di singoli settori scientifici, ma alla quale accedesse con facilità un vasto pubblico di persone colte e attivamente interessate a un tema ampio e generale come quello proposto, che tocca da vicino tutti noi. Pietro rispose con grande entusiasmo, come era nella sua natura generosa, e ci propose immediatamente, come sede dove ospitare il dibattito, la testata Il Bo Live, di cui era allora caporedattore, e ci seguì durante il lancio dell’idea e le prime fasi della sua realizzazione, tra l’altro scrivendo con noi l’articolo introduttivo. La collaborazione che si era stabilita prometteva di essere molto proficua, ma si interruppe bruscamente per l’improvvisa scomparsa di Pietro il 18 dicembre 2020, quando l’idea del dibattito era già lanciata e vari testi per la pubblicazione ci erano già pervenuti da parte degli studiosi a cui avevamo rivolto l’invito a partecipare.
La pubblicazione online della serie “La città dopo la pandemia” su Il Bo Live, iniziata con qualche ritardo per la scomparsa di Pietro Greco, si è protratta per nove mesi, da marzo a novembre di questo 2021, con un’interruzione nel mese di agosto. Ha visto la pubblicazione regolare e periodica sulla piattaforma, ogni lunedì a partire dal 1° marzo, subito dopo il nostro articolo introduttivo del 22 febbraio, e fino al 22 novembre, di un totale di 32 contributi, due dei quali, in considerazione delle loro dimensioni, pubblicati in due parti distinte, in due lunedì consecutivi. Ha visto la partecipazione di 36 autori, oltre a noi curatori: alcuni invitati da noi direttamente, altri proposti da amici comuni, altri ancora propostisi autonomamente. Nel momento in cui stiamo scrivendo questa conclusione, sono in corso i contatti preliminari con un importante editore nazionale per la pubblicazione di un libro, da noi curato, che raccoglierà l’integrale degli articoli pubblicati online su Il Bo Live nella serie “La città dopo la pandemia”. La pubblicazione a stampa avverrà con il sostegno della Fondazione Aldo Della Rocca di Roma, fondazione dedita agli studi di urbanistica, e avrà il patrocinio dell’Università di Padova, che ci ha cortesemente ospitato nel suo magazine.
Dato l’ampio numero di contributi, e soprattutto il vasto spettro dei temi toccati, degli argomenti discussi e dei settori disciplinari coinvolti, è impossibile offrire in questa sede un riassunto generale di quanto pubblicato nella serie-dibattito: inevitabilmente sarebbe troppo parziale e difficilmente renderebbe giustizia alla pluralità delle tematiche trattate, alla complessità e alle sfaccettature del pensiero espresso degli autori dei contributi su un tema così vasto e generale. Preferiamo, invece, in questa sede, proporre alcune nostre riflessioni conclusive, che si aggiungono alle numerose riflessioni già pubblicate nei contributi dei singoli autorevoli studiosi, che ancora una volta ringraziamo.
Epidemie, rivolte popolari e rinnovamenti urbani
Le più gravi epidemie molto spesso hanno lasciato un’impronta sull’aspetto delle città su cui periodicamente si sono abbattute, e sulla vita che vi si conduceva; ciò è accaduto in passato, in occasione dei grandi eventi catastrofici di questo tipo, e presumibilmente accadrà ora, come è stato a lungo discusso in questa serie-dibattito. Che fosse ‘la morte nera’ – la peste –, dal XIV al XVIII secolo, il ‘morbo asiatico’ – il colera –, a partire dalla fine degli anni ’20 dell’Ottocento, o la ‘spagnola’, negli anni 1918-1919, il ripetuto presentarsi di ondate epidemiche nei territori e nelle città in cui tali malattie non erano endemiche, ha modificato forma e vita delle città. La demolizione delle baraccopoli fatiscenti, l’ampliamento di strade e piazze, la realizzazione di reti fognarie e di approvvigionamento idrico, il reinsediamento del centro e una nuova zonizzazione nel territorio urbano di funzioni, servizi e abitazioni sono solo alcuni, i più tipici, dei cambiamenti avvenuti in risposta ai disastri subiti.
In questi ultimi due anni, Londra, Milano, Parigi, Mosca e New York, così come tutte le altre città che combattono oggi contro il Covid-19, sono già sopravvissute, com’è noto, a numerose e ripetute gravi epidemie frequentemente presentatesi nei secoli passati. Queste e altre città sono sopravvissute alla ‘morte nera’, al ‘morbo asiatico’, alla spagnola, e hanno superato il flagello di una tubercolosi endemica. Anche in relazione a ciò, sono cambiate nel corso del tempo sia nella loro forma fisica sia nei molti aspetti che a questa sono collegati. A Londra, ad esempio, dopo un’epidemia di peste del Seicento, che precedette di poco il grande incendio del settembre 1666 che distrusse gran parte del centro cittadino, si iniziarono attivamente a costruire case di pietra in luogo di quelle in legno, preda dei parassiti e facilmente soggette a prendere fuoco.
A partire dalla fine degli anni ’20 dell’Ottocento, le città europee affrontarono ripetutamente la nuova, terribile e da allora in poi sempre incombente minaccia di un nuovo morbo, fino a quegli anni mai presentatosi in Europa: il colera, malattia che da allora iniziò a esplodere ciclicamente in forme epidemiche, in particolare nelle città sovraffollate, in Europa e poi in America. Il colera dilagò in Europa, nel corso del solo XIX secolo, in una successione di ben sette epidemie. Queste si diffusero a ondate successive che iniziavano dal subcontinente indiano, in particolare dalla regione del delta del Gange, dove il colera era endemico, dilagavano nell’Asia meridionale e si dirigevano, al seguito degli spostamenti delle armate e lungo le vie dei commerci, in primo luogo verso l’Impero russo, che ne veniva costantemente investito. Sono tristemente note, a questo proposito, le vicende del corpo di spedizione militare sardo-piemontese in Crimea, durante la sua partecipazione alla guerra russo-turca del 1853-1956. Presente in Crimea solo per alcuni mesi, tra il 1855 e il 1856, il corpo di spedizione sardo-piemontese, che contava 18.000 uomini circa, ebbe oltre 2200 morti, fra i quali lo stesso Generale Alessandro La Marmora, causati dall’epidemia di colera – la terza delle sette – che vi incontrò, a fronte di una trentina di morti nei combattimenti e di altri 2000 circa deceduti per altre malattie (Di Ferdinando R., 2005, La spedizione piemontese in Crimea 1855-56, Rivista Italiana Difesa, n. 12, pp. 82-97). Dall’Impero russo, attraverso la Polonia e il Mar Baltico, sempre al seguito dei movimenti delle truppe o dei commerci, la seconda epidemia di colera negli anni 1829-1837 investì tutto il resto d’Europa (la prima epidemia dilagò in tutta l’Asia meridionale, toccando, in Europa, l’Impero russo a Sud, nella regione di Astrachan e del Mar Caspio). E poi ancora, al seguito dei migranti, dall’Europa l’epidemia si diffuse nelle Americhe. Dappertutto con conseguenze simili a quelle che le pestilenze avevano avuto nei secoli precedenti.
Interessante, ma non affatto sorprendente, è rilevare come le reazioni popolari, spesso violente, contro le misure messe in campo in quegli anni dalle autorità per limitare il dilagare del colera fossero caratterizzate da molti degli elementi che si osservano spesso, anche oggi. In particolare, le sommosse di piazza contro le istituzioni civili o religiose considerate incapaci, se non addirittura essere la causa intenzionale delle malattie. Le diffuse dicerie, che oggi chiameremmo fake news, secondo le quali, ad esempio, le epidemie erano deliberatamente scatenate dalle istituzioni o dai medici stessi, portavano a diffusa diffidenza e sfiducia verso la scienza medica, e in molti casi a violente ribellioni della popolazione colpita contro gli organi del potere e contro i medici. Nel 1831, ad esempio, durante la seconda epidemia di colera, scoppiarono ripetute rivolte di piazza a Parigi, a Londra, ad Aberdeen, ad Amburgo, a San Pietroburgo e in molte altre città, contro le drastiche misure adottate dalle autorità governative per combattere il diffondersi del colera – falò nelle strade, cordoni sanitari militarizzati, invio in massa di individui malati in centri di cura simili a carceri –, le quali, peraltro molto spesso violate, non risultavano sufficienti per spegnere il diffondersi del contagio. Sempre nel 1831, nella San Pietroburgo dello Zar Nicola I, una capitale imperiale che allora contava poco più di 300.000 abitanti, quando si sparse la voce secondo la quale il colera, in realtà portato dalle truppe russe di ritorno nella capitale dalla guerra russo-turca del 1828-29 per la conquista del Caucaso, sarebbe stato portato da medici stranieri per sterminare il popolo russo, una folla inferocita per le pesanti misure messe in atto dal governo zarista – quarantene, cordoni sanitari protetti dall’esercito, generale restrizione agli spostamenti – si riversò verso l’ospedale in cui erano raccolti e tenuti in isolamento i colerosi, lo devastò, lo diede alle fiamme, uccise vari medici e rilasciò i malati tenuti in isolamento. La concomitante rivolta polacca contro l’Impero russo, di cui larga parte dell’odierna Polonia era allora parte integrante, in corso negli anni 1830-1831, dette origine nella città di San Pietroburgo a un diffuso sentimento di odio verso i polacchi, soprattutto verso i numerosi ebrei polacchi, ai quali si iniziò presto ad attribuire la colpa del contagio in città. Le dicerie diffuse sostenevano che i polacchi avvelenassero giardini e pozzi di notte e che fossero in particolare i medici polacchi, quasi tutti i quali avevano studiato nelle università di Mosca o di San Pietroburgo, a scatenare il contagio; non di rado si ebbero episodi di linciaggio (McGrew R.E., 1965, Russia and the Cholera, 1823–1832, University of Wisconsin Press, Madison, WI).
Nell’Impero russo, in Francia, in Inghilterra e altrove non si tardò a riconoscere una chiara correlazione fra la diffusione del colera, in larga prevalenza negli strati poveri delle popolazioni urbane, la parte di gran lunga preponderante della popolazione, e le pessime condizioni igieniche e sanitarie in cui tali strati sociali vivevano, e a indurre le autorità a mettere in atto importanti provvedimenti mirati al risanamento urbano e alla creazione di ambienti fisici più sani. E ciò, ancora prima dei grandiosi interventi urbanistici che, dalla metà del secolo, caratterizzeranno molte città europee, a partire dalla Parigi del Barone Haussmann.
In Francia, ad esempio, numerosi studi e rapporti ufficiali, a partire dagli anni ’30 dell’Ottocento, gli anni in cui anche in Francia imperversava la seconda epidemia di colera, rilevavano con chiara evidenza che erano le classi più povere della popolazione ad essere le più colpite dal colera. Ma soprattutto, in anni in cui nulla si sapeva di microbiologia né era chiaro se ci si ammalasse di colera per contagio o per infezione, gli studi indicavano una causa di ciò proprio nel grave degrado dell’ambiente fisico in cui le classi più disagiate vivevano. Ad esempio, Louis-René Villermé, celebre medico ed economista sociale parigino, in una serie di studi e documenti scritti lungo un arco di oltre dieci anni (ad esempio: Villermé, 1840, Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de soie), dichiarava esplicitamente, in accordo con la maggioranza dei suoi colleghi, che la diffusione dei “miasmi” era favorita dalla mancanza di igiene e dal sovraffollamento, che la buona salute degli abitanti delle città richiedeva una vita in alloggi aerati, dove la pulizia personale e un’alimentazione sufficiente e sana fossero la regola, in condizioni di agio e con un livello di istruzione che proprio nei quartieri malsani mancavano. La malattia dilagava negli stretti vicoli parigini, per debellarla sarà necessario allargare le strade, costruire piazze, piantare ovunque alberi che «renderanno luce e vita a questi tetri quartieri, dove metà della popolazione conduce una misera esistenza, dove ovunque sono sporcizia e aria inquinata» (Papayanis N., 2004, Planning Paris Before Haussmann, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD).
Le richieste di una risposta politica divennero presto pressanti, ma il risanamento di interi quartieri, non era realizzabile in quegli anni. La legge sull’igiene delle abitazioni, che riconosceva il principio della salubrità delle abitazioni, incoraggiava misure di sviluppo che porteranno alla distruzione dei focolai di infezione e alla demolizione dei vecchi quartieri malsani di baracche sarà votata solo nel 1850, nel corso della terza epidemia di colera. Questa evidenzierà la medesima correlazione fra tassi elevati di mortalità e quartieri di degrado igienico e povertà – la stessa ‘geografia delle morti’, si diceva – già evidenziata nell’epidemia di colera nel 1832. Ciò, in anni in cui non si sapeva ancora se gli individui si ammalassero di colera per contagio, come molti medici sostenevano, o per infezione, come molti altri affermavano. Le indagini sociali confermano comunque, incontestabilmente, l’importanza per la salute della qualità dell’ambiente e in particolare dell’abitazione. A fianco del dibattito fra i sostenitori dell’idea che ci si ammali di colera per contagio e quelli che ritengono che ci si ammali come risultato di infezione, disputa che in quel momento non ha ancora alcuna base scientifica – il batterio responsabile del colera sarà scoperto nel 1854 dall’anatomista italiano Filippo Pacini e sarà isolato nel 1884 dal medico tedesco Robert Koch, il quale dimostrerà il ruolo dell’acqua come agente di trasmissione della malattia – trionfa il concetto di igiene pubblica, con l’idea che “i miasmi” possano essere propagatori di colera e che questi circolino in particolare nei luoghi malsani. Questo sarà uno dei più importanti elementi in favore del rifacimento del centro di Parigi, che inizierà di lì a poco.
In quegli stessi anni furono allestiti parchi nelle città d’Europa e d’America, sia come elemento fondamentale per un ambiente urbano confortevole sia come soluzione per rendere l’aria più pulita. A New York, ad esempio, fu presa la decisione di creare il Central Park dopo l’epidemia di colera del 1848-1849. La zona era una vasta palude: per prosciugarla si rese necessario un esteso sistema di drenaggio delle acque, realizzato con il deposito di 7 milioni di metri cubi di terreno e la piantumazione di oltre 270.000 fra alberi e arbusti. La gara per la costruzione di Central Park fu vinta nel 1858 da Frederick Lowe Olmsted e Calvert Vox, proprio sull’idea che si faceva sempre più strada anche nell’America di quegli anni, in corso di rapida industrializzazione, che le persone dovessero vivere in ampi quartieri simili a parchi, idea che già da tempo aveva iniziato a diffondersi in Europa, che aveva portato alla comparsa delle prime utopie urbanistiche e che porterà in seguito alla progettazione delle prime garden city (Bertuglia C.S. e Vaio F., 2019, Il fenomeno urbano e la complessità. Concezioni sociologiche, antropologiche ed economiche di un sistema complesso territoriale, Bollati Boringhieri, Torino 2019). Alla fine del XIX secolo, l’attenzione degli urbanisti americani si rivolse agli enormi e sovraffollati caseggiati di edilizia popolare, i tenement, diffusi nelle grandi città nordamericane, privi spesso di accessi diretti all’aria e alla luce esterna in molti degli appartamenti situati nelle parti interne degli edifici. Le autorità riconobbero i grandi tenement come focolai di diffusione della tubercolosi, ordinando ai proprietari di installare in ogni caseggiato pozzi di ventilazione e ampi cortili interni. Gli sviluppatori risposero erigendo edifici sempre più alti, in particolare sui lotti d’angolo fra le vie. Tutto ciò è visibile ancora oggi nelle vecchie zone residenziali di Manhattan. Nel 1908 si tenne a New York la mostra “Crowding Show”, il cui obiettivo era convincere le autorità che il sovraffollamento stesso contribuisce alla diffusione della tubercolosi. Le argomentazioni convinsero il Governatore dello Stato: in dieci anni fu sviluppato un piano urbanistico che rese molto più spaziosi i distretti in rapida crescita di Brooklyn e del Queens.
A Londra, il Victoria Embankment, l’argine che costeggia il Tamigi sul lato Nord, nel centro della città, considerato oggi uno dei segni distintivi della capitale britannica, che era già riprodotto nelle prime cartoline di Londra, nel XIX secolo, era descritto come una caratteristica paesaggistica ben progettata e degna della fiorente e industrializzata Inghilterra vittoriana. Quello stesso terrapieno, in realtà, è un prodotto dell’epidemia: sotto di esso è situato il sistema fognario che si iniziò a costruire dopo la terza epidemia di colera nella capitale britannica, esplosa nel 1850, che causò oltre 10.000 vittime. Sotto la guida di Joseph William Basalgette furono posati oltre 2000 km di tubi per raccogliere le acque reflue e convogliarle fuori dalla città.
Ancor prima di quegli anni, un’altra disastrosa epidemia era stata all’origine di una profonda rivoluzione urbanistica: l’epidemia di peste che si abbatté su Mosca negli anni 1770-1772: di fatto, l’ultima epidemia di peste che colpì l’Europa. La Mosca del Diciottesimo secolo era, per l’epoca, una città popolosa, molto densamente abitata, priva di qualsiasi ordine urbanistico, sviluppatasi convulsamente a partire dalla sua struttura medievale; una ex capitale situata in un enorme impero estremamente arretrato sul piano sociale ed economico, con poche città di rilievo e una sterminata campagna. Le proprietà nobiliari e le case dei ricchi mercanti, a Mosca, erano ancora di legno, come le baracche dei poveri. L’alta densità di popolazione, la diffusa sporcizia, le pessime condizioni igieniche, in particolare in relazione all’acqua dei pozzi e dei fiumi della città, da tempo inquinata e gravemente infetta, le sepolture dei cadaveri entro i confini urbani (nella Mosca del XVII secolo vi erano più di duecento cimiteri parrocchiali) contribuivano pesantemente alla diffusione delle malattie (Martin A.M., 2008, Sewage and the City. Filth, Smell, and Representations of Urban Life in Moscow, 1770-1880, The Russian Review, 67, n. 2, pp. 243-274). Verso la fine del 1770 scoppiò in città una violentissima pestilenza, arrivata a Mosca attraverso l’Ucraina e la Moldavia durante una delle campagne belliche russo-turche, causando in città una elevatissima mortalità, anarchia, panico diffuso e sommosse. Si calcola che la peste, in quella Mosca che non raggiungeva i 200.000 abitanti, abbia ucciso, fra il 1770 e il 1772, tra 50.000 e 100.000 persone. Nel picco dell’epidemia, i cadaveri erano abbandonati per strada a migliaia ogni giorno; obbligati alla loro raccolta erano i detenuti delle carceri, vestiti in abiti impregnati di catrame, chiusi e dotati di buchi per gli occhi e la bocca. Di quella terribile pestilenza, disponiamo di una efficacissima testimonianza nella Mémoire sur la peste, scritta dal giovane medico militare ucraino Danilo Samojlovič e da lui dedicata alla Zarina Caterina II, pubblicata a Parigi, presso Leclerc, nel 1783 (recentemente ripubblicata in varie edizioni, la Mémoire sur la peste è integralmente disponibile on line all’archivio digitale della University of Maryland). Nella Mémoire, Samojlovič, avendo egli vissuto in prima persona l’epidemia nella città, fornì sia descrizioni dettagliate dal punto di vista clinico, il primo studio di tal tipo in Russia, sia il resoconto storico degli avvenimenti occorsi sia precise indicazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-urbanistico per circoscrivere il contagio; ciò, in un’epoca in cui non era nemmeno accertato se la peste colpisse le persone per contagio diretto, che avrebbe reso indispensabili i cordoni sanitari, o per infezione, che li avrebbe resi inutili. Samojlovic, di passaggio per servizio a Mosca durante l’epidemia, vi si fermò per dedicarsi allo studio e alla cura della malattia; con le sue osservazioni esposte nella Mémoire e con i suoi studi successivi, gettò le basi della epidemiologia in Russia, di cui oggi è considerato il padre.
Nel settembre 1771, in piena pestilenza, a Mosca scoppiò una sanguinosa rivolta popolare, in relazione alla quale si possono riconoscere vari elementi – tipicamente: l’ostilità e la ribellione contro le autorità sanitarie e politiche, l’attenzione della gente rivolta più alle dicerie popolari che non alla scienza medica –, che talora si manifestano anche oggi, come reazioni popolari di ribellione contro i provvedimenti sanitari delle autorità e contro gli esponenti della scienza, come il dilagare di fake news e così via. La fede popolare venerava come miracolosa l’icona della Madonna di Bogoljubovo, una copia della quale, risalente ai tempi dello Zar Pietro I, era conservata in una cappella presso la Porta di Santa Barbara che dava accesso a Kitaj-Gorod, lo storico quartiere dei mercanti di Mosca (il quartiere era allora circondato da mura, quasi completamente demolite negli anni ’30, nel quadro del rinnovamento urbano di Mosca voluto da Stalin). All’inizio di settembre una numerosa folla di fedeli iniziò a raccogliersi alla Porta di Santa Barbara per baciare l’icona miracolosa che si credeva avrebbe liberato la città dalla peste, e per portare offerte. L’arcivescovo di Mosca Ambrosius, comprendendo che l’affollarsi delle persone, animate dall’intenzione di baciare l’icona, avrebbe enormemente diffuso il contagio, proibì le preghiere e ordinò che l’icona fosse rimossa. Il denaro donato fu messo sotto sigillo perché considerato fonte di infezione. Il 15 settembre si scatenarono i disordini di piazza: migliaia di persone armate in modo rudimentale, convinte che l’arcivescovo avesse rubato le donazioni, si raccolsero nella vicina Piazza Rossa, irruppero nel Cremlino e, al suo interno, assaltarono e devastarono il Monastero Čudov, residenza dell’arcivescovo. Il giorno successivo, la folla in rivolta si riversò al Monastero Donskoj, uno dei principali monasteri moscoviti, presso il quale l’arcivescovo si era rifugiato. Il monastero fu preso d’assalto, la folla trovò l’arcivescovo e lo uccise in un brutale linciaggio. Una parte dei rivoltosi andò a distruggere gli edifici di isolamento di quarantena e gli ospedali: in uno di essi i ribelli tentarono il linciaggio di Danilo Samojlovič, che, ferito, riuscì fortunosamente a salvarsi. Lo stesso 16 settembre truppe armate a cavallo entrarono in città per sedare la rivolta popolare, che cessò dopo tre giorni di devastazioni e linciaggi, durante i quali furono uccise circa un centinaio di persone.
Su ordine della Zarina Caterina II, nel 1772 fu costituita una commissione, guidata dal Conte Grigorij Orlov, favorito della zarina e comandante militare inviato a Mosca per sedare la rivolta, incaricata di studiare le cause della diffusione della peste a Mosca e le misure per combatterla, come l’isolamento forzato degli individui affetti dal morbo o con sintomi sospetti. Della commissione era membro lo stesso Samojlovič: su sua esplicita indicazione, fu stabilito un rigido cordone sanitario che impedì alla peste di arrivare alla capitale San Pietroburgo, che non fu raggiunta dal contagio.
È da sottolineare come in Francia, patria dell’illuminismo e della scienza, i medici in quegli anni fossero divisi fra coloro che affermavano la peste trasmettersi per contagio e coloro che lo negavano. Fra questi ultimi, la parte dominante, vi erano, in particolare, gli appartenenti alla celeberrima e autorevole Scuola di medicina di Montpellier, alcuni dei quali avevano lavorato a Marsiglia negli anni 1720-1722, durante l’ultima terribile epidemia di peste che colpì l’Europa, prima di quella di Mosca del 1770-1772. I sostenitori di questa opinione dominante continuarono per tutto il secolo a esprimere disaccordo in tema di misure, come il cordone sanitario, messe in campo contro la trasmissione per contagio, tanto che, intorno alla metà del secolo, il chimico e medico Gabriel-François Vernel scriveva nell’Encyclopédie alla voce «Contagion», di cui era estensore: «Nulla è forse meno deciso in medicina che l’esistenza o la non esistenza del contagio di quest’ultima classe di malattie, e di molte altre che il popolo crede contagiose senza il minimo dubbio, e che molti medici dichiarano non contagiose senza aver abbastanza dubitato» (Tomo 4, p. 91).
Insieme al cordone sanitario, una delle prime misure adottate a Mosca fu, per decreto di Caterina II, lo spostamento dei cimiteri fuori città, in aree situate all’esterno di quello che oggi è “il terzo anello” di Mosca, creando una decina di nuovi cimiteri tuttora esistenti. E ciò, una trentina di anni prima dell’Editto di Saint Cloud (Décret Impérial sur les Sépultures), emanato da Napoleone nel 1804. Fu affrontato anche il gravissimo problema dell’approvvigionamento idrico della città: nel 1779, ancora per decreto di Caterina II, si iniziò a costruire un nuovo acquedotto, che sarà inaugurato nel 1804: l’acquedotto Rostokinskij, rimasto in funzione fino ai primi anni 2000, oggi monumento nazionale situato all’interno di un vasto parco che porta il suo nome, in una zona semicentrale della Mosca contemporanea.
Dopo la visita della zarina a Mosca, fu messo a punto un nuovo piano urbanistico per la città, confermato da Caterina II nel 1775, che prevedeva zone centrali pedonali, la sistemazione delle rive dei fiumi della città, che furono in parte rivestite in pietra, e la demolizione delle strutture fatiscenti che si trovavano sulla riva del fiume Moskva nei pressi del Cremlino e nel quartiere Kitaj-Gorod. La zarina sognava di fare di Mosca una città europea, con bei terrapieni, comodi viali e ampie piazze, grandiosi palazzi e tenute. La città risorse dal punto di vista urbanistico, traendo profitto anche del fatto che migliaia di appezzamenti di terreno urbano che erano rimasti senza proprietari, scomparsi senza eredi nel turbine della pestilenza, furono incamerati dallo Stato e ceduti a ricchi mercanti o alla nobiltà, che vi edificarono nuovi palazzi e tenute (si vedano: Alexander J.T., 1974, Plague in Russia and Danilo Samoilovich. An Historiographical Comment and Research Note, Canadian-American Slavic Studies, VIII, n. 4, pp 525-531; Alexander J.T., 2003, Bubonic Plague in Early Modern Russia. Public Health and Urban Disaster, Oxford University Press, Oxford; Alexander M.M., 2013, Enlightened Metropolis. Constructing Imperial Moscow, 1762-1855, Oxford University Press, Oxford).
Sul futuro della città dopo la pandemia
L’attuale pandemia di Covid-19, come quasi tutte le pandemie, ha colpito soprattutto le città. Di questo si è lungamente discusso negli articoli pubblicati in questa serie. Come si è detto, alcuni urbanisti prevedono la morte delle megalopoli. Joel Kotkin, ad esempio, urban scientist alla Chapman University di Orange (California), ritiene che il coronavirus accelererà la fine dell’era delle metropoli, come scrive in «The Coming Age of Dispersion», pubblicato nell’edizione online di Quillette. Kotkin ritiene che città “contagiose” come New York perderanno la loro attrattiva. Assisteremo a una nuova e necessaria dispersione di persone, che avrà luogo non solo verso le aperte vastità del Nord America o dell’Australia, scrive ancora, ma anche a partire dalle megalopoli dei Paesi in via di sviluppo. È sicuramente possibile che ciò accada nel ricco e sviluppato Occidente, concordiamo con l’autore; ma, forse, abbiamo qualche riserva nel ritenere probabile che ciò accada in riferimento alle enormi baraccopoli africane, sudamericane o dell’Asia meridionale, dove le società e loro dinamiche, differenti in molti aspetti e per molte ragioni da quelle dei paesi sviluppati, difficilmente, riteniamo, porteranno alla dispersione della popolazione urbana dalle megalopoli, anche in epoca di Covid-19 e nell’immediato futuro.
Tuttavia, la storia insegna che le grandi città si trasformano, si riducono, riprendono a crescere, ma non scompaiono. Richard Florida, urban scientist dell’Università di Toronto, osserva, a questo proposito, come la pandemia di spagnola nel 1918-1919 non abbia affatto arrestato, in America, l’enorme sviluppo di Chicago, di New York o di Filadelfia. Inoltre, il Covid-19 ha colpito non solo le megalopoli, ma anche le città minori, i piccoli centri turistici, e le case di cura situate nelle periferie. Ancora Joel Kotkin, nel libro The City. A World History (Random House, New York 2005), sottolinea come, fin dalla loro nascita, le città mirassero, fondamentalmente, a facilitare il soddisfacimento dei tre principali bisogni dell’umanità: commercio, governo e culto religioso. Questi bisogni sopravvivono ancora oggi, e sopravviveranno ancora: le città dunque non scompariranno, ma semplicemente cambieranno. Come sempre è accaduto dopo eventi di questo tipo.
Uno dei principali motori del cambiamento urbano cui assisteremo, come ribadito da molti degli autori che hanno contribuito a questa serie-dibattito, sarà il passaggio al lavoro a distanza. Questa tendenza, in realtà, come è stato ripetutamente osservato in questa serie-dibattito, era già emersa chiaramente prima della pandemia. E se, prima della pandemia, la tendenza al telelavoro era sostenuta principalmente da aziende impegnate in settori del terziario avanzato, come pubblicità, design, marketing e supporto tecnico per la vendita a distanza, oggi sono le società commerciali dell’energia e del settore finanziario in generale ad essere attivamente occupate della gestione del lavoro a distanza. E, oggi, sono soprattutto i cosiddetti “millennial” istruiti, che si stanno allontanando dalle città in cui gli alloggi sono troppo costosi.
Se non c’è bisogno di spostarsi per lavoro, allora si può vivere in periferia o anche più lontano, in provincia. Cosa significa questo per le grandi città? Come si è discusso a lungo, se le persone trascorrono più tempo nella zona in cui vivono, allora non vi acquisteranno solo un appartamento, ma sceglieranno un’area con infrastrutture adeguate, di alta qualità. Se le persone lavorano da casa, allora gli appartamenti dovranno avere più luce, dovranno essere costruiti con materiali meno tossici di quelli impiegati finora, e dovranno avere intorno un maggior numero di piante.
Con il primo diffondersi della pandemia a New York, i prezzi degli affitti nelle città sono diminuiti drasticamente, le transazioni immobiliari stesse sono diminuite: le persone hanno lasciato in fretta la costosa città sovraffollata per lavorare da casa, ma in un posto più vicino alla natura. Sulla stampa locale sono apparsi articoli con titoli risonanti: «È giunta la fine delle città?» Certamente no! sostiene l’architetto britannico Lord Norman Foster, autore di numerosi edifici “iconici” in tutto il mondo, anche a New York. Foster ha parlato al «Forum of Mayors» promosso dalla Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, tenutosi al Palais des Nations di Ginevra nell’ottobre 2020. Alla conferenza hanno partecipato, in presenza o in teleconferenza, sindaci dell’Europa, del Nord America, delle repubbliche dell’Asia centrale e del Caucaso. Lord Foster ha ribadito che la storia delle città è una storia di crisi e una storia di cambiamenti: densità di popolazione, ricchezza, innovazione, abbondanza di opportunità sono tuttavia, soprattutto per i giovani, elementi di attrazione costanti, che restano. Il principale vantaggio delle città è un’infrastruttura ben sviluppata: una “colla urbana” di strade, parchi, alberi e di tutto ciò che collega gli edifici e dà origine a un “paesaggio urbano”. Molti dei sindaci che hanno parlato al «Forum of Mayors» hanno ribadito non solo l’impegno generale sul fronte epidemiologico e climatico (una priorità assoluta: le città consumano circa il 60% dell’energia del pianeta e generano il 70% delle emissioni di gas serra), ma in particolare le iniziative sociali rivolte agli strati deboli delle loro società urbane e volte a favorire la mobilità pubblica attraverso il miglioramento della rete dei trasporti locali.
Una pandemia, quando termina, non costituisce solo un impulso per lo sviluppo, ma è anche un’opportunità per un salto di qualità: una crisi, di regola, accelera tendenze che si sono già manifestate in una determinata località. Così è stato perfino per la pandemia di peste, che a metà del Trecento uccise un terzo della popolazione europea: le grandi e popolose città di allora persero gran parte degli abitanti, evidentemente, ma non scomparvero affatto, e al termine della pestilenza si iniziarono a gettare le basi di una grandiosa rinascita economica e culturale dell’Europa, che fece da preludio all’Umanesimo e al Rinascimento.
La nuova generazione oggi non ha fretta di acquisire proprietà, non ha la fretta di arrivare “a possedere”, come era invece per le generazioni precedenti, che vedevano la ricchezza nel possesso della casa e dell’automobile: “il possedere” come espressione del benessere, come status di vita, come immagine di ricchezza e di successo. La tendenza oggi è la mobilità: la circolazione di merci, di persone e di informazioni. La nuova generazione non aspira tanto “a possedere” quanto piuttosto a utilizzare servizi non in proprietà. I giovani abitanti delle città, anche se benestanti, sempre meno acquistano automobili e sempre più ricorrono a forme di noleggio e di condivisione di auto e di biciclette; e soprattutto sempre più ricorrono ai servizi di trasporto pubblico, almeno nelle città in cui tali servizi sono efficienti e adeguati alle richieste di mobilità.
Ma, alla luce del lavoro svolto da casa, non c’è più bisogno di andare dall’altra parte della città in ufficio, tutto ciò che è necessario – un bar, una lavanderia, una biblioteca, un ristorante, un cinema, un teatro, un asilo nido, una scuola, i negozi di beni essenziali, un efficace servizio sanitario pubblico di base – dovrebbe essere raggiungibile a piedi. Ciò, evidentemente, è di particolare significato nelle città di grandi dimensioni. Questa tendenza esiste da tempo a New York e, come discusso in questa serie-dibattito, sotto differenti punti di vista, si va diffondendo anche nelle nostre città europee.
In che modo il Covid-19 ha cambiato il modo in cui pensiamo alla vita? A quali conseguenze a breve e lungo termine può portare l’esperienza della lotta contro quest’ultimo coronavirus? Quali professioni saranno richieste in futuro? Quali aree dell’economia dovrebbero ricevere investimenti? Più in generale: quali riforme saranno necessarie? Ci vorrà tempo prima che le persone tornino a sentirsi a proprio agio nel riunirsi di nuovo nei teatri, ai concerti e agli eventi pubblici, ma a questo torneremo comunque. Alle persone piace stare con altre persone. Sotto questo punto di vista, siamo stati fortunati almeno nel fatto che questa pandemia da Covid-19 sia avvenuta nell’era tecnologica. Ciò ci ha fornito l’opportunità di continuare a comunicare fra noi a distanza malgrado l’isolamento fisico, ci ha consentito di celebrare feste, feste di famiglia, e di continuare a lavorare. Se ciò fosse accaduto solo pochi decenni fa, sarebbe stato molto, molto peggio. Lo stato attuale delle cose non ci dà un’idea di come sarà la nostra vita in futuro. Fondamentalmente, noi umani siamo creature sociali: la tecnologia è utilissima, indiscutibilmente, ma non sostituisce i modi in cui la maggior parte di noi ama interagire con gli altri. Non appena sarà possibile, cominceremo a riunirci di nuovo, non virtualmente, ma nel mondo reale.
La pandemia ha evidenziato le vulnerabilità delle nostre società. Ad esempio, la logistica è una delle aree principali in cui potremmo aver bisogno di più persone con capacità di pianificazione. Molte aziende, paesi, città incontrano problemi nella gestione dei flussi di informazioni, dei flussi umani e delle merci. I sistemi di approvvigionamento nel nostro mondo sono più complessi che in qualsiasi altro momento della storia umana.
Ma oltre alla logistica, altre aree di studio e ricerca hanno richiamato grande attenzione durante la crisi di questi anni, fra queste vi sono sicuramente la virologia e la biologia sintetica, ma anche l’ingegneria genetica e la biologia computazionale. E, naturalmente, non da ultima, l’intelligenza artificiale. Sarà necessario, forse, un maggior numero di specialisti in questi (e altri) settori? Ciò richiederà una riorganizzazione dei nostri sistemi scolastici? È sicuramente possibile. Questa pandemia, tuttavia, potrebbe anche dimostrare che sarà invece la domanda di professionisti polivalenti a crescere. Ad esempio, di specialisti esperti sia di biologia sia di intelligenza artificiale, con elevata competenza matematica e informatica, in grado di sviluppare modelli altamente complessi. O di studiosi e professionisti capaci di comprendere a fondo le catene globali di approvvigionamento, i cambiamenti climatici, o la situazione del mercato alimentare globale. Segnerà questo un allontanamento dalla direzione che si sta seguendo in questo ultimo secolo verso le iperspecializzazioni, e un possibile ritorno all’ “uomo medievale” che sa ed è competente in materie diverse? Può darsi.
La pandemia ha dato un grande impulso alle persone che pensano a cosa si può fare online. Ha dimostrato che siamo tutti dipendenti l’uno dall’altro: un evento nel mercato da qualche parte nel centro della Cina ha il potenziale per influenzare seriamente la vita nel centro di Roma. La presa di coscienza del fatto che possiamo essere salvati, o morire, solo insieme, come società e come umanità, sarà forse l’eredità a lungo termine che ci lascerà la pandemia. Questo verrà dall’esperienza personale, secondo la quale la “tua” uscita di casa mette in pericolo la vita dei “tuoi vicini”. Qualcosa di simile successe al termine della seconda guerra mondiale, quando divenne chiaro al mondo intero che non potevamo permettere che ciò che era accaduto si ripetesse. E che l’unico modo per evitarlo era (ed è!) lavorare insieme, prendendosi cura non solo dei vicini, ma anche delle persone che vivono dall’altra parte del mondo.
La pandemia in corso e, in particolare, la minaccia di nuovi contagi per le mutazioni del virus stanno dunque portando alla consapevolezza che si deve ripensare la città in una prospettiva sostenibile di rifondazione dei suoi principi costitutivi. L’orientamento prevalente sembra essere, oggi, verso una città, come si usa dire, “a misura d’uomo”, caratterizzata dal prevalere delle reti collaborative di prossimità: una città solidale per convenienza sociale, più che non per convinzione morale.
La città è un sistema complesso, caratterizzato da un livello di complessità estremamente elevato, fra i più elevati osservabili nei sistemi naturali e in quelli sociali. È un sistema composto da un numero elevatissimo di parti componenti, soggette ciascuna a innumerevoli interazioni con tutte le altre parti del sistema città, in forme di tipo ben difficilmente quantificabile o traducibile in formule. La città è un sistema complesso che evolve spinto, soprattutto ma non solo – come, nella storia, hanno drammaticamente mostrato guerre ed epidemie fra le quali quest’ultima –, da forze interne, endogene: un sistema complesso che mostra continuamente fenomeni emergenti e stati più o meno temporanei di equilibrio autorganizzativo, e talora anche turbolenze. Non è possibile governare la città in modo esclusivamente dirigistico, come era tendenza comune in passato, senza che essa finisca per spegnere la propria vitalità: la moderna scienza della città si fonda su concezioni articolate, sviluppatesi a partire da numerose discipline differenti, dall’architettura alla scienza dei trasporti, all’economia, alla sociologia e alla psicologia sociale e individuale, alla sanità e alla medicina, e così via. Occorre rovesciare il punto di vista tradizionale e partire “dal basso” per governare la città, anche e soprattutto in una fase critica come quella innescata dalla pandemia che si è abbattuta sulla città come un elemento esogeno: indagare nelle aree ove si è in contatto con la realtà, la realtà urbana, in continua trasformazione, ad esempio dove si formano spontaneamente comunità solidali, relazioni collaborative di vicinato, iniziative di prossimità dei servizi in un raggio di percorrenza pedonale o ciclabile, limitata nel tempo. L’urgenza della riorganizzazione territoriale del servizio sanitario nazionale, resa evidente dalla crisi in cui è stato posto dalla pandemia, può essere una fertile occasione per una ampia riflessione sui servizi di prossimità. Questo è un importante messaggio, forse il più importante, certamente non l’unico, che possiamo trarre al termine di questa serie-dibattito sul futuro della città dopo la pandemia. Occorre dunque sviluppare gli studi sulla città sistema complesso, anche a partire dai metodi di simulazione di singoli fenomeni o di limitati insiemi di fenomeni. Non c’è, al momento attuale, un sistema logico-deduttivo per i sistemi complessi, al quale possiamo riferirci per tracciare l’evoluzione futura dei sistemi complessi, fra cui la città. Disponiamo di efficaci tecniche informatiche per le simulazioni, che mettono lo sperimentatore in condizioni di tener conto sia di aspetti regolari dei fenomeni fisici sia dei comportamenti mutevoli e variegati degli individui in interazione fra loro, come è stato mostrato in un contributo di questa serie-dibattito con un efficacissimo esempio. Occorre proseguire le ricerche, a supporto delle necessarie decisioni strategiche, soprattutto in questa fase storica di lenta, ma ormai evidente uscita da una fase di crisi sociale e urbana.